
Clicca sulla cover per l’acquisto
Innanzitutto è bene precisare che L’americano tranquillo (The Quiet American, 1955) non è un saggio di geopolitica. Lo stesso Greene nell’introduzione al romanzo, dedicandolo a René e Phuong, due suoi carissimi amici, dice che non ci sono alcune controparti reali ai suoi personaggi, e che anche i fatti storici sono in parte rimaneggiati, insomma questo è un racconto non un libro di storia.
Ciò non toglie che un racconto di personaggi immaginari possa fare trasparire in filigrana personali convinzioni dell’autore, ovvero molto spesso scherzando si dice la verità, ma appunto distinguere fantasia e realtà in un romanzo non è un’impresa così facile e soprattutto priva di rischi. Si potrebbe iniziare a leggere tutti gli articoli che Greene scrisse come corrispondente di guerra per “The Sunday Times” e “Le Figaro” durante la guerra d’Indocina, facendo raffronti e comparazioni, o le sue lettere private, quasi con l’entusiasmo di un entomologo, ma ne vale davvero la pena? Non che non lo si possa fare naturalmente, ma lasciamo agli storici questo compito, noi accontentiamoci di trascorrere una delle tante sere afose di Saigon.
Un’altra questione che vorrei affrontare, non certo con leggerezza, riguarda le polemiche e le accuse di antiamericanismo, misoginia, e irresponsabilità che gli furono fatte da più parti all’uscita del romanzo (fu pubblicato per la prima volta in Gran Bretagna nel 1955 da William Heinemann Ltd. e solo l’anno dopo negli Stati Uniti da Viking Press). Polemiche sicuramente virulente negli anni ’50, in piena caccia alle streghe, che oggi hanno perso parte dello slancio lasciando in tutti, critici e lettori, la convinzione che Un americano tranquillo è una riuscita opera letteraria, meritevole di apprezzamento appunto per il suo valore artistico. Affermazione quest’ultima forse non del tutto veritiera se si pensa che l’uscita del film di Noyce del 2002, molto fedele al libro (sicuramente più del film di Joseph L. Mankiewicz del 1958) fu ritardata per i fatti dell’ 11 settembre del 2001. Insomma il libro, e i film da esso tratti, hanno ancora oggi una componente di tale portata da essere giudicati pericolosi, o destabilizzanti. Potere della letteratura.
Per avvicinare i lettori a questo libro credo sia comunque necessario inquadrare il romanzo nel periodo storico in cui fu scritto, giusto per ricordare chi furono i Viet Minh, chi fu Ho Chi Minh, in che regioni si estendeva l’Indocina, cosa portò alla battaglia di Dien Bien Phu. Giusto una traccia e uno spunto, insomma, per chi vorrà in futuro documentarsi.
Che nel romanzo si parli di colonialismo francese, comunismo, imperialismo americano, antimilitarismo, terrorismo è indubbio, i temi etici e politici sono senz’altro parte dell’intreccio, anzi ne costituiscono il tema portante, ma non dimentichiamoci che il libro si può anche benissimo leggere senza conoscere niente della situazione del Sud-est asiatico degli anni ’50, che portò se vogliamo alla guerra del Vietnam, e Greene sembra vedere le chiare premesse (sottolinea più volte il concetto di Terza forza) di questa deriva descrivendo le imprese coperte già in atto nel paese, e forse proprio il suo doppio ruolo di giornalista e di spia gli dava se vogliamo una posizione privilegiata per analizzare e interpretare i fatti. Solo molto più tardi, anche in America, si sviluppò un certo spirito critico se non un aperto dissenso verso il coinvolgimento americano nel Sud-est asiatico, disinnescando in un certo senso la portata delle tesi di Greene. E allora le sue parole acquisteranno sì solo più una sorta di preveggenza o per lo meno di attenta lungimiranza.
Ma potrei dire di più, una certa universalità, slegata ai fatti contingenti della guerra del Vietnam, proprio un certo atteggiamento di critica verso la condotta etica e morale, collegabile al kipliniano fardello dell’uomo bianco, di autoinvestitura dell’America come esportatrice di diritto e democrazia, e di cibi energetici, coca cola e armi (come ironizza Greene) ci riporta alla più stretta attualità. L’ America come gendarme del mondo dunque, ruolo che tutt’ oggi ha conseguenze tutt’altro che trascurabili nelle vicissitudini del nostro tormentato pianeta. Detto questo, si può leggere comunque il romanzo anche come una storia d’amore, come un giallo poliziesco, come un romanzo di formazione, un esotico libro di viaggi. Insomma le letture sono molteplici e tutte legittime. Ogni lettore trovi la sua strada interpretativa.
Ma tornando al mio piccolo quadro riassuntivo del periodo storico, innanzitutto partirei col dire che l’ Indocina del 1950 assimilava gli odierni stati della Cambogia, del Laos, della Thailandia, della Birmania, della Malesia e del Vientnam. La parte orientale dell’Indocina, comprendente a vario titolo Vietnam, Laos e Cambogia, rientrava dall’ottobre del 1887 nelle dinamiche colonialiste francesi, dinamiche di sfruttamento economico, sudditanza commerciale e culturale, che Greene certo non approfondisce, ma a cui velatamente accenna. Dopo alterne vicende nel 1946 la Francia riprese il controllo dell’Indocina ma già Ho Chi Minh, a capo di un movimento comunista e indipendentista – nazionalista noto come Viet Minh, pone le basi per la guerra d’Indocina, combattuta dal 1946 al 1955, che portò dopo la battaglia di Dien Bien Phu, alla totale disfatta francese, e alla fine del suo sistema coloniale. Francia e patrioti (o ribelli) vietnamiti, a secondo dei punti di vista, furono i soldati sul campo, ma la vera guerra tra alleanze, aiuti, e balletti della diplomazia, fu combattuta tra Stati Uniti, e Unione sovietica e Cina. Tutti stati seduti allo stesso tavolo della conferenza di pace di Ginevra del 1954. Trattato di pace che lasciando tutti scontenti portò quasi senza logica di discontinuità alla guerra del Vietnam, combattuta dal 1955 al 1975.
Un americano tranquillo uscì nel 1955, dopo una gestazione di alcuni anni, proprio all’inizio di quella guerra che leggendo il libro sembra inevitabile. Tre sono i personaggi principali: Thomas Fowler, cinico e disilluso reporter inglese di stanza a Saigon, voce narrante della storia; Alden Pyle, agente della CIA sotto copertura (ufficialmente lavora per una fantomatica Missione per gli aiuti economici), in Vietnam per creare proprio quei presupposti che avrebbero portato ad un intervento diretto americano; e Phuong, giovane vietnamita amante prima di Fowler, e poi di Pyle, che promette di sposarla e garantirle una vita sicura e onorevole in America.
Il romanzo inizia con la notizia della morte di Pyle, e grazie a una serie di flashback che ci riportano a un passato filtrato dagli occhi di Fowler, ricostruisce pian piano le motivazioni che portarono a questo delitto, scoprendo se Fowler (e in quale misura) fosse coinvolto. Uno schema classico, classico almeno per Greene che già nel Terzo uomo lo presentò: un’amicizia tradita, una donna contesa, un contesto politico difficile. Pyle comunque ha ben poco dell’antagonista Harry Lime, la Vienna occupata, ben poco della Saigon colonialista, ma nonostante tutto lo spirito sembra il medesimo, Greene sembra continuare un discorso precedentemente iniziato, almeno a livello artistico.
Fowler non è un eroe, può in un certo senso richiamare una proiezione dell’autore stesso, forse più che altro per alcuni atteggiamenti, ma resta un personaggio di fantasia, una creazione strumentale all’intreccio, utile alla narrazione e se anche non ci fidassimo delle premesse dell’autore, lo scopriremo durante la lettura, quando il suo doppio e triplo animo si dipana durante la storia, creando un meccanismo perfetto di suspense e dissimulazione, godibile per il lettore, anche il più smaliziato, e ammirevole da un mero punto di vista narrativo.
L’ambiente giornalistico intorno al Continental è sicuramente realistico, nato dai ricordi di Greene, da quel mood cinico e senza illusioni di una comunità di espatriati, riuniti al capezzale di una guerra che sono pagati per documentare con i loro articoli mandati per telegramma, depurati dalla censura, portati sui campi di battaglia come chiassose classi di studenti in gita, assistendo a conferenze stampa pilotate, dove ottenere vere notizie o anche solo disvelamenti è una cosa più unica che rara.
Tutti recitano un ruolo, lo stesso ruolo di Fowler, l’uomo senza opinioni, l’uomo che non si lascia coinvolgere, l’ateo convinto, mosso solo dal suo personale egoismo visto come un’unica ancora di salvezza giustificata dalla disperazione e dalla solitudine.
Il suo stesso amore per Phuong quasi non si spiega. Come lei ce ne sono molte, donne vietnamite disponibili a intrattenere rapporti con gli occidentali. Phuong infondo è una donna senza apparenti particolari qualità a parte la giovinezza e la bellezza. Il suo mistero resta inaccessibile, lo stesso Fowler si stanca presto di cercare di penetrare i suoi pensieri, di vedere cosa si agita nella sua mente. Phuong a tratti può sembrare quasi un contenitore vuoto, che colleziona sciarpe colorate, che ammira la famiglia reale inglese, di cui sfoglia in continuazione riviste e libri illustrati, che lascia un uomo per mettersi con un altro senza drammi, concedendo il suo corpo con indifferenza, preparando le pipe d’oppio priva di morali resistenze. Fondamentalmente ignorante, in questo simile a Pyle, anche se Fowler sembra giudicare l’ignoranza un effetto condizionato della giovinezza, calcolatrice, attenta più che altro al suo benessere materiale, a tratti insensibile, anche se Fowler raccomanda a Pyle di non trattarla come un bel oggetto, di non farla soffrire, perché anche lei ha sentimenti, emozioni, anche se la compostezza tutta orientale che l’anima sembra negarlo.
L’accusa di misoginia potrebbe essere sensata, se non si percepisse, anche distintamente, in questa quasi totale snaturalizzazione del personaggio, il riflesso di un’idea. Phuong non è una donna, ma lo spirito stesso del Vietnam, occupato, colonizzato, sfruttato, diviso. Un paese che cerca di sopravvivere, e si adatta a risorgere dalle sue ceneri. In questo la metafora della Fenice, non sembra limitarsi al significato letterale del nome o alla piacevolezza del suo suono o alla facilità di pronunciarlo per un occidentale come sembra sostenere Greene. Il Vietnam è destinato a risorgere sembra al contrario dirci l’autore, dopo anni di sfruttamento coloniale, alle soglie di una guerra ancora più devastante di quella già in atto, che nessuno può evitare, o forse manco ci si prova.
L’antimilitarismo di Greene è radicale, la guerra è il pianto di un uomo nel buio, potente raffigurazione che colpisce nel profondo il lettore più che la descrizione di corpi dilaniati, cadaveri ingrigiti, e innocenti sanguinanti. Forse più ancora della madre che nasconde con il cappello il cadavere del figlio dopo l’attentato nella piazza di Saigon. Odio la guerra, Greene fa dire con disperazione a Fowler, dopo l’attacco al piccolo sampan, sgretolando definitivamente la sua apparente indifferenza e il suo cinismo. Quando il capitano Trouin ci parla dei bombardamenti al napalm, (Si vede la foresta che va a fuoco. Sa Dio cosa si vedrebbe stando a terra. Quei poveri diavoli bruciano vivi, le fiamme gli arrivano addosso come una marea. Annegano nel fuoco) passano nella mente inevitabilmente i fotogrammi del film Apocalypse Now ponendo fine a ogni riflessione sul concetto di guerra giusta.
Il personaggio di Pyle, a cui Fowler, pur dichiarandosi suo amico e nutrendo del vero affetto, non evita una battuta di vendicativo scherno (mi immaginavo i suoi occhi molli e un po’ canini. Avrebbero dovuto chiamarlo Fido, non Alden) con tutte le sue valenze simboliche e metaforiche, si discosta grandemente dal villain classico. E’ un ragazzone americano giovane, con le gambe dinoccolate, i capelli tagliati a spazzola, e lo sguardo aperto, da studente universitario, (…) incapace di fare del male. E’ serio, corretto, idealista, coraggioso (salva la vita a Fowler a rischio della propria), quando se ne innamora vuole proteggere Phuong, lontano anni luce da molti suoi simili che vedono nelle donne vietnamite meri oggetti di piacere. Ma è tragicamente ingenuo e colpevolmente innocente. Tutto quello che sa dell’Estremo Oriente l’ha imparato dai libri (anche quello che sa del sesso e forse dell’amore l’ha unicamente imparato dai libri). E’ imbottito di concetti astratti sui dilemmi della Democrazia e le responsabilità dell’Occidente, concetti presi di sana pianta dai libri di York Harding (scrittore inesistente, naturalmente inventato da Greene) che racchiude in sé i tanti commentatori politici, apertamente anticomunisti, veicoli di propaganda, più che di convinzioni profonde. E solo l’ingenuo Pyle può considerare York Harding (se cercate un colpevole Vigot, è lui l’assassino di Pyle) un profeta, detentore delle più salde e incrollabili verità. Pyle è totalmente privo di spirito critico, ed è questa fondamentalmente l’accusa che Fowler gli rivolge, la sua assurda innocenza (chi può dirsi innocente a quel punto della guerra), la sua certezza di essere nel giusto, (anche quando donne e bambini cadono sul campo) il suo giustificare la propria inettitudine (doveva controllare che la parata fosse stata rimandata). Nel definirlo un americano tranquillo, (la prima è Phuong a farlo) Greene paradossalmente accentua l’ironia amara che stigmatizza chi fa danni suo malgrado, anzi con le migliori intenzioni, e lo stesso Vigot, della Suretè francese, lo definisce così alludendo al fatto che è freddo e rigido nella sala mortuaria.
E poi c’è il Vietnam che inevitabilmente Greene ama, di un amore capace di far provare nostalgia quando ancora vi ci vive (pur sapendo che molto presto sarà altrove). Il suo clima afoso, le zanzare, le pipe d’oppio, le ragazze in bicicletta con i pantaloni di seta bianca e le lunghe vesti attillate a fiori, le vecchie in pantaloni neri intente a spettegolare, le risaie, il tè servito a ogni ora come forma di ospitalità, le parate variopinte dei caodaisti, i guidatori di risciò, i tavolini all’aperto dei bar, tutto l’esotico scenario già presente nelle sue cronache giornalistiche, che qui riporta fedelmente con lo stesso rispetto e dignità e un velato senso di colpa, (noi inglesi siamo colonialisti di vecchia data tanto quanto i francesi).
Chiudo dicendo che se vi avvicinate a Greene per la prima volta, L’ americano tranquillo, può essere il libro che vi farà innamorare perdutamente di questo autore, con le sue contraddizioni, la sua fede tormentata, la sua lucidità integra e onesta, e la sua capacità di trovare le parole giuste in ogni circostanza, a cui ci si avvicina con una certa invidia, la stessa di Vigot quando cerca le parole sul piano della scrivania, parole capaci di esprimere i suoi pensieri con la mia stessa precisione.
Nuova traduzione di Alessandro Carrera ripresa dalla prima edizione I Meridiani del giugno 2000, pubblicata a partire dalla terza ristampa, condotta sul testo autorizzato della Collected Edition, la serie di volumi che Heinemann e Bodley Head pubblicarono tra il 1970 e il 1982 con l’imprimatur dell’autore.
Greene Graham (Berkhamsted, Inghilterra, 1904 – Vevey, Svizzera, 1991), convertitosi al cattolicesimo intorno al 1926, è tra i narratori inglesi novecenteschi più popolari. Giornalista e inviato speciale, ma anche autore di teatro e sceneggiatore per il cinema, Graham Greene è famoso soprattutto per i suoi romanzi, come Il potere e la gloria (1940), Il terzo uomo (1950), Il nostro agente all’Avana (1958) e Il console onorario (1973). Tutte le sue opere principali sono pubblicate negli Oscar Mondadori.
Source: acquisto personale.
Disclosure: questo post contiene affiliate link di Libreriauniversitaria.


 “Abbiamo fatto tutti la guerra senza amarla, ma anche senza far storie”
“Abbiamo fatto tutti la guerra senza amarla, ma anche senza far storie”







 Innanzitutto che esistano una quantità spropositata di qualità di sigari, ognuna con il proprio nome, e le proprie qualità, e da non fumatrice è una cosa che mi ha sorpreso. Sigmund Freud ne fuma continuamente, e sempre diversi e costosi. Poi che Papa Leone XIII fosse un cultore, o proprio un adepto del vino Mariani, un vino medicinale corretto con la Cocaina del Perù, e ne era così entusiasta che prestò la propria immagine per locandine pubblicitarie dell’epoca (vedesi foto). Che già agli inizi del Novecento si usasse una forma rudimentale di poligrafo, (anche Lombroso si ingegnò a perfezionarlo), capace di rendere evidente se il soggetto dell’indagine mentisse o dicesse al verità. Che tra massoni si salutasse in un determinato modo, e non ostante la scomunica immediata, se scoperti, molti alti prelati lo fossero. Che Leone XIII fu il papa più longevo (e simpatico) della storia. Che Francesco Giuseppe, Imperatore del Sacro romano Impero, esercitò un antico diritto lo Ius Veti, per impedire l’elezione di un papa a lui sgradito (impedì anche la sepoltura in terra consacrata del figlio Rodolfo, morto suicida). Che la ditta Annibale Gammarelli è la più antica sartoria romana, e che da secoli veste papi e cardinali.
Innanzitutto che esistano una quantità spropositata di qualità di sigari, ognuna con il proprio nome, e le proprie qualità, e da non fumatrice è una cosa che mi ha sorpreso. Sigmund Freud ne fuma continuamente, e sempre diversi e costosi. Poi che Papa Leone XIII fosse un cultore, o proprio un adepto del vino Mariani, un vino medicinale corretto con la Cocaina del Perù, e ne era così entusiasta che prestò la propria immagine per locandine pubblicitarie dell’epoca (vedesi foto). Che già agli inizi del Novecento si usasse una forma rudimentale di poligrafo, (anche Lombroso si ingegnò a perfezionarlo), capace di rendere evidente se il soggetto dell’indagine mentisse o dicesse al verità. Che tra massoni si salutasse in un determinato modo, e non ostante la scomunica immediata, se scoperti, molti alti prelati lo fossero. Che Leone XIII fu il papa più longevo (e simpatico) della storia. Che Francesco Giuseppe, Imperatore del Sacro romano Impero, esercitò un antico diritto lo Ius Veti, per impedire l’elezione di un papa a lui sgradito (impedì anche la sepoltura in terra consacrata del figlio Rodolfo, morto suicida). Che la ditta Annibale Gammarelli è la più antica sartoria romana, e che da secoli veste papi e cardinali. Alle fronde dei salici comparve per la prima volta nel 1946, a Milano, nella raccolta Con il piede straniero sopra il cuore, in “Quaderni di costume” di Giancarlo Vigorelli. Poi nel febbraio del 1947 fu pubblicata da Mondadori nella raccolta Giorno dopo giorno.
Alle fronde dei salici comparve per la prima volta nel 1946, a Milano, nella raccolta Con il piede straniero sopra il cuore, in “Quaderni di costume” di Giancarlo Vigorelli. Poi nel febbraio del 1947 fu pubblicata da Mondadori nella raccolta Giorno dopo giorno. Cigolii, passi affrettati nel buio, ombre, presenze inquietanti, delitti, misteri, di questo si nutre Il palazzo dalle cinque porte, romanzo che segna il passaggio da Segretissimo al Giallo Mondadori, di un autore versatile e non scontato come Stefano Di Marino.
Cigolii, passi affrettati nel buio, ombre, presenze inquietanti, delitti, misteri, di questo si nutre Il palazzo dalle cinque porte, romanzo che segna il passaggio da Segretissimo al Giallo Mondadori, di un autore versatile e non scontato come Stefano Di Marino.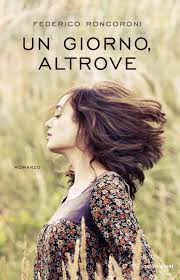 Ho sempre pensato che un giorno ti saresti rifatta viva. L’ho pensato, sperato, desiderato, sognato, e, certe volte, anche temuto. Adesso che il momento è arrivato non so cosa dire, né cosa pensare. Curiosa la vita, eh?
Ho sempre pensato che un giorno ti saresti rifatta viva. L’ho pensato, sperato, desiderato, sognato, e, certe volte, anche temuto. Adesso che il momento è arrivato non so cosa dire, né cosa pensare. Curiosa la vita, eh?
























