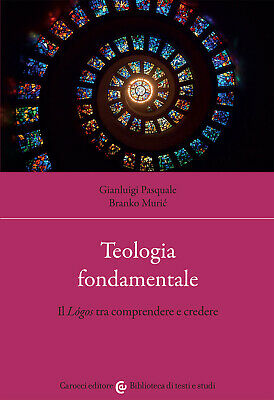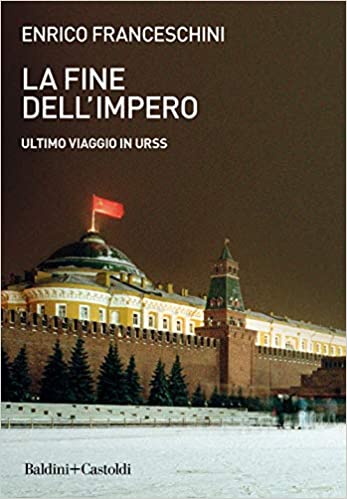Benvenuto professore Di Rienzo su Liberi di scrivere e grazie di avere accettato questa nuova intervista. Tra le sue molte opere è anche l’autore di un libro uscito nel 2015, ormai sette anni fa, Il conflitto russo-ucraino. Geopolitica del nuovo (dis)ordine mondiale, edito da Rubbettino, di cui maggiormente ne stiamo scoprendo l’importanza in questi giorni difficili. Dunque le varie tregue, sempre tenuto conto del Donbass, non erano che il preludio dello stallo di questi giorni. Lei essenzialmente, professore, è uno storico, può ricapitolarci sotto il profilo storico la storia dell’Ucraina, per avere una visione di insieme più nitida e lucida?
Quando il territorio dell’Ucraina fu spartito tra l’Impero russo e asburgico, si ebbe una frattura all’interno di questo Paese, poiché la parte nord-est guardò a Kiev, all’Occidente, mentre quella sud-orientale guardò verso la Russia, e ospitò cittadini prevalentemente russofoni. Un altro discorso è invece quello della Crimea, russa dal 1792. Nel 1918, dopo il trattato di pace di Brest-Litovsk tra la Russia guidata dal governo rivoluzionario presieduto da Lenin e gli Imperi centrali, l’Ucraina di Kiev diventa indipendente de jure, ma non de facto, in quanto stato satellite della Germania guglielmina. Dal 1922, l’Ucraina divenne una Repubblica Sovietica, Crimea compresa, la più importante, forse, tra quelle che componevano l’Urss. Nella Seconda Guerra Mondiale, quando il territorio ucraino venne invaso dalle truppe tedesche, si replicò nuovamente questa divisione, l’Ucraina di Kiev tornò ad essere uno Stato satellite della Germania nazista. Addirittura venne formata una Divisione SS composta da cittadini ucraini che combatterono a fianco dei nazisti insieme con la Guardia Nazionale ucraina. È doveroso ricordare che questi due gruppi armati diedero man forte alla persecuzione degli ebrei. Dopo la morte di Stalin, nel 1954, Mosca cedette la Crimea all’Ucraina, che in quel periodo era ancora inglobata nel territorio russo. Fu come un regalo che si fa a una moglie. Tutto rimase in famiglia fino al dicembre 1990 quanto i leader di Bielorussia, Russia e Ucraina dissolsero formalmente l’Urss e costituirono Stati indipendenti insieme a sette altre Repubbliche sovietiche
Rileggendo la sua precedente intervista, (per chi fosse interessato questo è il link ), alla luce dei fatti odierni molte sue affermazioni prendono una nuova luce. Non si può parlare di Ucraina senza parlare di Crimea, e da storico sicuramente ha bene in mente il conflitto combattuto tra il 1853 e il 1856, tra l’allora Impero russo e l’Impero ottomano, la Francia, la Gran Bretagna e il Regno di Sardegna (con il ruolo attivo di Cavour). La vera paura di Putin, secondo lei, è perdere la Crimea (e il conseguente sbocco nel Mar Nero)?
I timori di Putin riguardano l’accerchiamento della Russia da parte della NATO, in gran parte già realizzato e in via di potenziarsi con il prossimo ingresso nell’alleanza di Svezia, Finlandia e Georgia. Naturalmente il Premier russo teme anche la perdita della Crimea, entrata a far parte della Federazione Russa dopo il referendum sull’autodeterminazione, vigilato da osservatori ONU, del 16 marzo 2014, e con essa quella della base navale di Sebastopoli che sola consente, attraverso gli Stretti Turchi, alla Voenno-morskoj Flot l’accesso al Mediterraneo, durante i mesi invernali, restando la gran parte dei porti russi del Mare del Nord e del Baltico gelati e quindi impraticabili in quella stagione. Vorrei ricordare che da Sebastopoli sono partiti truppe, rifornimenti, logistica che hanno consentito alla Forze armate della Federazione Russa di raggiungere la Siria e di spezzare, una volta per tutte, le reni all’autoproclamatosi Stato Islamico, mentre i contingenti americani e NATO si limitarono a osservare lo scontro dalla finestra.
Può parlarci più diffusamente del patto denominato “not one inch” e sulla sua reale tenuta, e sul fatto che nonostante rimase solo verbale (un “accordo tra gentiluomini” che davano valore alla parola data) dalla Russia fu sempre tenuto in seria considerazione e disatteso, nei fatti, dalla NATO.
Nel marzo 2004, l’Unione Europea festeggiò l’allargamento della sua sfera a ben dieci nazioni, di cui quattro (Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Ungheria) ex membri del Patto di Varsavia e tre (Estonia, Lituania, Lettonia), già parte integrante dell’Urss sia pure per diritto di conquista. Questa espansione non avrebbe avuto nulla d’irrituale se, tra 1999 e 2004, questi stessi Stati, con l’aggiunta di Bulgaria e Romania, non fossero divenuti membri della NATO, un’alleanza che, in ossequio alla sua stessa primitiva ragione sociale, avrebbe dovuto essere sciolta dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica. Evidentemente Bill Clinton e George W. Bush avevano deciso di non onorare la promessa fatta da George Bush senior a Michail Gorbaciov, quando il Presidente statunitense lo persuase a consentire che la Germania unificata entrasse a far parte della NATO assicurandogli, come contropartita, che la coalizione atlantica non avrebbe esteso la sua presenza oltre la vecchia «cortina di ferro».
Quando cadde il Muro di Berlino e l’Europa orientale cominciò a emanciparsi dal regime comunista, il primo Bush incontrò Gorbaciov nel summit di Malta (2-3 dicembre 1989). I due statisti si accordarono per rilasciare un comunicato congiunto della massima importanza dove, sulla base degli accordi raggiunti durante i colloqui, si concordava sul fatto che l’Unione Sovietica dovesse rinunciare a ogni intervento per sostenere gli agonizzanti sistemi comunisti dell’Est, mentre gli Stati Uniti s’impegnavano a non ricavare alcun vantaggio strategico dagli sviluppi politici conseguenti alla decisione del Cremlino.
Si trattò di un gentlemen’s agreement che allora non fu formalizzato per iscritto, ma i cui contenuti si possono evincere dal verbale del colloquio tra i due premier, nel punto in cui Bush senior, garantiva il suo interlocutore che i profondi cambiamenti politici in corso non avrebbero danneggiato la posizione internazionale della Russia. L’esistenza del cosiddetto «accordo di Malta» fu poi confermata dalle dichiarazioni del Primo ministro inglese, del Cancelliere tedesco, del Presidente francese e dalla testimonianza dell’allora ambasciatore statunitense a Mosca, Jack Foust Matlock.
Più di recente, dopo un lungo periodo di enigmatico silenzio, lo stesso Gorbaciov è tornato su questo punto. Rimproverandosi tardivamente per la passata ingenuità, il penultimo Segretario generale del Partito comunista dell’Unione Sovietica ha espresso il rammarico che quell’impegno sia rimasto un semplice accordo verbale senza trasformarsi in un’esplicita convenzione diplomatica dove si sarebbero potute recepire anche le assicurazioni fornitegli allora dal segretario di Stato, James Baker, subito dopo la caduta del Berliner Mauer, secondo le quali «la giurisdizione della NATO non si sarebbe allargata nemmeno di un pollice verso Oriente». Come tutte le intese sulla parola, l’accordo stipulato nella piccola isola del Mediterraneo può essere sottoposto a molteplici interpretazioni ma non azzerato nella sua sostanza. Il significato storico del compromesso tra Urss e Occidente era tutto nelle parole pronunciate da Baker: da una parte, la Russia rinunciava alla sua egemonia sull’Europa orientale e, dall’altra, gli Stati Uniti non avrebbero in alcun modo approfittato di tale concessione per allargare la loro influenza su quel grande spazio e minacciare la sicurezza strategica russa.
Lo spirito di Malta fu poi ancora più profondamente tradito dalle pressioni americane per l’ingresso dell’Ucraina e della Georgia nella NATO, esercitate durante il vertice atlantico di Bucarest dell’aprile 2008, alle quali sarebbe seguita la guerra russo-georgiana. Alcuni governi europei si sforzarono di attenuare il clima di crescente tensione. Nella capitale romena, Berlino arrivò a ritardare la discussione sull’ingresso di Ucraina e Georgia nell’Alleanza Atlantica e più tardi, a Tbilisi, Parigi, dopo l’inizio del conflitto georgiano, riuscì a negoziare un armistizio che permise a Mosca di conservare il controllo dell’Ossezia meridionale e dell’Abkhazia.
Nulla e nessuno poterono però impedire prima la dichiarazione d’indipendenza del Kosovo da Belgrado (febbraio 2008), apertamente favorita da Stati Uniti e Cancellerie occidentali, che costituì un vulnus non rimarginabile per la Russia colpita nel suo antico, storico ruolo di protettrice dell’integrità della Nazione serba, poi l’adesione al Patto Atlantico di Albania e Croazia, che avvenne nel 2009 sotto la presidenza Obama, e infine la ripresa dei negoziati finalizzati a integrare Georgia, Montenegro, Kosovo, Moldavia nella NATO.
Dunque l’entrata dell’Ucraina nella NATO sembra la causa del contendere, mentre una sua neutralità o meglio finlandizzazione sarebbe la soluzione più auspicata. Perché l’Ucraina non abbraccia apertamente questa soluzione?
A mio avviso, Kiev sarebbe disposta ad accettare questa soluzione, a riconoscere l’autonomia delle Repubbliche filorusse del Donbass e a concedere un ininterrotto approvigionamento idrico della Crimea, più volte sospeso in questi ultimi anni, pur di evitare un conflitto con la Federazione Russa e il suo completo crollo economico. Se si analizzano i comunicati diramati dal Governo ucraino, in queste ultime settimane, si vedrà che quei comunicati stigmatizzano con grande decisione le esternazioni statunitensi e britanniche che danno per certa l’invasione russa, dichiarando che tali boatos hanno il solo scopo di innalzare il livello della tensione e rendere impossibile un accordo bilaterale russo-ucraino. Accordo al quale Parigi, Berlino e forse anche Roma stanno lavorando. Resta, però, il fatto che l’Ucraina, divenuta dopo il 2014 un Failed State, completamente dipendente dalle rimesse della finanza americana, è ormai divenuta una «Nazione marionetta», alla quale non è concesso prendere decisioni che non siano avallate da Washington.
In una sua recente intervista accenna alla cosiddetta Maskirovka, anche soprannominata “guerra delle ombre”, adottata dalla Russia, in contrapposizione a una guerra “calda” che gli risulterebbe fatale. Non pensa anche lei che Putin sia l’ultimo a volere una guerra aperta, insomma ha troppo da perdere? O pensa che sia così ingenuo da ritenere che occupando l’Ucraina NATO e Stati Uniti lo lascino fare?
A un osservatore superficiale Putin potrebbe sembrare una sorta di «apprendista stregone». In realtà, il Premier russo ha ben calibrato la sua linea d’azione. Non intende certo arrivare fino a Kiev e si accontenterebbe della neutralità dell’Ucraina, del riconoscimento formale del possesso della Crimea e dell’applicazione degli accordi di Minsk (settembre 2014-febbraio 2015), per quel che riguarda il Donbass dove da 7 anni infuria una sanguinosa guerra civile, del tutto ignorata dai media occidentali, che si è trasformata in guerra contro i civili filorussi. Se tutte le sue richieste saranno respinte, come ormai pare quasi certo, il Cremlino si limiterà, per così dire, a occupare militarmente il Donbass e forse la costa meridionale del Mare d’Azov che assicurerebbe il collegamento terrestre tra Federazione Russa e Crimea. Anche in questo caso la NATO probabilmente non interverrà direttamente in Ucraina. Si avrà solo un incremento delle sanzioni che, però, allo stato attuale, danneggeranno più Francia, Germania, Italia che la Russia. Ma queste sono supposizioni, fatte mentre la partita è ancora aperta. E io sono uno storico, non un profeta.
La Francia di Macron ha cercato una mediazione, e l’Italia, pensa che in qualche modo possa assumere un ruolo di mediatore? Sarebbe ascoltato?
Dato che ormai il Presidente del Consiglio Mario Draghi detta in completa autonomia anche la nostra politica estera, bisognerebbe girare la domanda a lui. Comunque dalle parti della Farnesina credo che qualcosa si stia muovendo, come dimostrano i colloqui tra Draghi e Macron. Anche se un Paese, come il nostro, che ha rinunciato ad avere un’autonoma politica estera dal 2011, non potrà certo essere l’attore principale della trattativa.
Quali sono le richieste russe, che il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che sono state disattese? Sono richieste fattibili?
Mi sembra di averle già elencate. Comunque, la finlandizzazione dell’Ucraina, già auspicata da Kissinger nel 2014, sarebbe del tutto fattibile, se non gli fosse d’ostacolo la hỳbris degli Stati Uniti.
Il fronte NATO e quello dell’UE è diviso, questo mi sembra un punto di debolezza difficilmente mediabile, la Russia in che modo approfitta di questa crepa?
I Big Three della NATO e dell’UE (Italia, Francia, Germania), sono contrari alla politica aggressiva contro Mosca a cui sono propensi invece, Stati Uniti, Regno Unito, Polonia e Stati baltici, sia perché la Federazione Russa è un loro importantissimo partner commerciale sia per la dipendenza energetica dalla Grande Nazione Euroasiatica sia ancora per le loro difficoltà interne. Ma lo sono anche, seppur in misura meno evidente, Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia. Mosca spera che questa crepa si trasformi in frattura. Si tratta al momento, però, di una speranza poco realizzabile considerata la forte egemonia politica, economica e finanziaria americana sul Vecchio Continente, e la presenza di un forte partito amerikano, in una parte delle classi dirigenti europee, fanaticamente atlantiste che scambiano ancora, per insipienza o per malafede, la Russia di Putin con quella di Stalin.
Come ultima domanda le chiedo che ruolo sta avendo la Cina in questa crisi? Sta a guardare per intervenire, magari, al fianco della Russia? Non è un pericolo troppo grande da non tenere in debito conto?
Se si arrivasse alla guerra guerreggiata in Ucraina, Pechino invaderebbe immediatamente Taiwan, il conflitto diverrebbe globale e gli Stati Uniti dovrebbero battersi su due fronti. In questo caso credo che Washington non si limiterebbe all’uso di armi convenzionali e si potrebbe arrivare (Dio non voglia!) all’Armageddon nucleare.
Grazie del suo tempo e delle sue risposte, invito i nostri lettori anche a leggere, se ancora non lo hanno fatto, il suo libro Il conflitto russo-ucraino. Geopolitica del nuovo (dis)ordine mondiale per approfondire l’argomento.
Roma, 13 Febbraio 2022