
Clicca sulla cover per l’acquisto
Titolo originale: Death of a Salesman
Autore: Arthur Miller
Anno di pubblicazione: 1979
Traduzione a cura di: Gerardo Guerrieri
Introduzione di Elena De Angeli
Casa editrice: Giulio Einaudi Editore
Nel teatro di Miller l’uomo comune e la vita di ogni giorno vengono nobilitati e acquistano valenza epica. Oltre a usare strumenti di analisi psicologica, l’originalità di Miller sta nell’introdurre metodi di analisi antropologica, sociologica, economica, e politica – non dimenticando di filtrare tutte le scuole di teatro precedenti- cercando di cogliere ciò che di meglio hanno prodotto.
Rifiuta il teatro come mera forma di intrattenimento e rivendica la sua natura di rappresentazione della vita contemporanea e pretesto per analizzare argomenti di interesse pubblico e politico, sull’esempio del teatro sociale di Ibsen.
Inoltre inizia a elaborare un’ idea del teatro come laboratorio di formazione, cercando di sviluppare un senso critico nei suoi spettatori, coinvolgendoli sia intellettualmente che emozionalmente, fornendo strumenti per riflettere, per formare giudizi liberamente, acquistando così una coscienza critica e indipendente, strumento necessario e indispensabile per ottenere la vera libertà. Miller si interessa prevalentemente agli aspetti tragici del reale per dare più forza e veridicità alle sue opinioni.
Detto questo, che mi sembrava in un certo senso necessario, inizierò ad analizzare “Morte di un commesso viaggiatore”, pietra miliare del teatro americano del dopoguerra. Sicuramente l’opera teatrale più conosciuta e rappresentata di Miller e, nella sua apparente semplicità, la più complessa e difficile sia per struttura, sovrapposizione di tempi, analisi psicologica dei personaggi.
Tema conduttore di tutto il testo è il dualismo tra realtà e sogno e come questa contrapposizione si risolve nella mente del protagonista, e per riflesso nei personaggi a lui collegati.
La trama di Morte di un commesso viaggiatore è molto semplice: l’intera opera si limita a essere una parabola morale che parte da un inizio di falsa sicurezza, si dispiega in un processo di autocoscienza, che porterà il protagonista nel suo punto massimo di consapevolezza nel momento del licenziamento, oltre al quale tutto si orienta irrevocabilmente verso il tragico epilogo del finale. Più in dettaglio narra la vita di Willy Loman, un tipico rappresentante di commercio, mediocre esponente di un’ intera classe sociale che vive nel mito del “Denaro” e del “Successo” come unica ragione di vita e affermazione.
Loman è il tipico uomo qualunque, senza particolari qualità che lo caratterizzino, anzi racchiude in sé più difetti che pregi, ma nello stesso tempo è animato da una profonda onestà che, a discapito dei falsi idoli che venera e per cui spreca la sua vita, gli fornirà la sua unica occasione di riscatto.
Proprio la sua onestà ne conserva la dignità e gli impedisce di diventare l’uomo di successo, eroe del Sogno americano, caricaturalmente delineato nella figura del fratello Ben, sicuro di sé, spavaldo, conscio del suo valore, l’uomo capace di cogliere le opportunità, ma animato dalla certezza che per vincere bisogna trattare gli altri da nemici e non giocare pulito con loro.
Loman, esponente di quella middle class frustrata che non riesce a emergere dalla sua mediocrità inseguendo il classico Sogno Americano, l’Alaska terra dell’oro, l’Eldorado consumistico che promette falsi paradisi di benessere, serenità e felicità, dedica tutta la sua vita inseguendo quel sogno, popolato solo da illusioni e progetti irrealizzabili, per poi accorgersi che tutto era solo un miraggio, solo fumo, e che le cose concrete che veramente contano gli sono sfuggite e non c’è più modo di tornare indietro a recuperarle. Questo senso del tempo perduto viene sottolineato dall’uso incrociato del passato e presente, coesistenti nella mente del protagonista. Non a caso il titolo originario dell’opera doveva essere proprio “Dentro la sua testa”.
Il “common sense ”, il modo giusto e normale di vedere le cose, viene dissolto e si stempera in un’apparente incoerenza, sintomo della sua mente ormai disturbata e della sua identità distrutta che lo porterà inarrestabilmente al suicidio. Loman sente la vecchiaia assalirlo, sente le forze abbandonarlo e guardando in sé non trova niente che veramente valga. Ripercorre la sua vita, che sperava costellata di grandi imprese, costellata invece di squallidi atti senza importanza. La sua intera vita spesa a comprare quel sogno, costellata solo di meschinità e mediocrità, di rate e cambiali, di conti, di debiti, ora lo ripaga tradendolo e non tributandogli nemmeno quel minimo di considerazione, che in realtà è la sola cosa che ha sempre cercato.
 La sua famiglia, che è tutto il suo mondo, è composta, oltre che dalla moglie, da due figli: Happy che presto si sposerà sicuramente avviato a ripercorrere i suoi errori, e Biff che nel tentativo di affermare la sua identità e la sua scala di valori è riuscito solo a diventare un ladro per reazione, non trovando niente di veramente positivo oltre alla ribellione da contrapporre ai valori paterni.
La sua famiglia, che è tutto il suo mondo, è composta, oltre che dalla moglie, da due figli: Happy che presto si sposerà sicuramente avviato a ripercorrere i suoi errori, e Biff che nel tentativo di affermare la sua identità e la sua scala di valori è riuscito solo a diventare un ladro per reazione, non trovando niente di veramente positivo oltre alla ribellione da contrapporre ai valori paterni.
La figura di Biff soprattutto si eleva tra le altre e pone Loman di fronte a uno specchio distorto di se stesso. Non essere riuscito a trasmettergli i suoi valori di onestà, di rettitudine, laboriosità lo pone seriamente a prendere coscienza di quanto il suo panorama morale sia limitato e fragile. Vedere i suoi sogni di sportivo fallire, i suoi vagabondaggi inutili, che l’hanno portato a essere senza casa, lavoro e prospettive sono l’unico fallimento dal quale non sa riprendersi.
Infine la moglie Linda, l’unico suo sostegno, la sola che tenga veramente a lui, anche lei ormai è vecchia e senza alcuna prospettiva di trascorrere gli ultimi anni della sua vita in serenità.
Nonostante questa lenta presa di coscienza, Loman si ostina a credere di avere ancora un’altra occasione, che il suo lavoro, con cui afferma la sua identità, non è inutile e la sua clientela, che ha coltivato negli anni cercando di farsi amare e benvolere, continueranno a dare uno scopo, e un senso, alla sua esistenza. Il crollo e la disintegrazione della sua identità avverrà quando il giovane Howard Wagner, titolare della sua ditta, lo licenzia senza preavviso e senza fornirgli alcuna liquidazione o indennizzo, abbandonandolo alla più completa miseria con la giustificazione “gli affari sono affari”.
Loman parla da solo, confonde presente e passato, soffre di allucinazioni e annaspa nel suo lungo calvario che lo accomuna agli uomini di ogni epoca, tormentato dalla lenta percezione dell’assurdo, del tradimento, dell’ingiustizia insita in una promessa non mantenuta. Dopo aver speso una vita per gli altri, al servizio dei suoi clienti, per la famiglia, per l’azienda, per il paese che in un certo modo ha contribuito a costruire, fisicamente usurato, con la vecchiaia che avanza, vede la sua ricompensa trasformarsi in condanna, vede i suoi figli persi, sua moglie destinata alla miseria, l’irriconoscenza e il cinismo dei datori di lavoro, il biasimo della società. La sua vita non raggiunge un compimento, l’uomo che sognava di essere si è dissolto.
Quando si lamenta “Non c’è niente di seminato nel mio pezzetto di terra, il mio giardino è senza piante” afferma il diritto e nello stesso tempo il dovere di dare concretezza alla sua umanità, un segno del suo passaggio, costruendo qualcosa non per sé ma per gli altri, superando il suo egoismo con l’unico atto eroico di cui è capace, sacrificare la sua vita per permettere alla moglie di percepire l’assicurazione.
La morte gli consente la sua ultima occasione di riscatto e liberazione da una vita mediocre, permettendogli di affermare il valore della sua persona e trasformandolo da semplice e volgare piazzista in un “uomo”. Il protagonista condizionato dall’ambiente in cui vive accetta acriticamente e persegue una filosofia materialistica che fa dei soldi e del mito del successo un idolo vendicativo e crudele.
Willy non è un eroe nel senso classico del termine, anzi è pieno di difetti, e anche la sua scelta finale, seppure determinata da buone motivazioni, non è dall’autore della piece del tutto giustificata. La vita, la famiglia, gli affetti sono più importanti della sicurezza economica e il non capirlo decreterà la grande sconfitta e la inesorabile tragicità di quest’uomo irrimediabilmente solo. I personaggi non comunicano realmente tra loro. Un senso di grande solitudine, infatti, pervade tutta l’opera. L’unica interazione reale, che supera l’isolamento in cui i personaggi si trovano, è il rapporto conflittuale tra Biff e suo padre, costellato da litigi, separazioni, abbandoni, ritorni che pur tuttavia permette di manifestare sentimenti sinceri. Quando realizza che suo figlio non lo odia, Willy percepisce che il suo fallimento non è completo, che qualcosa di sacro è riuscito a conservare e proprio questo se vogliamo è la molla che farà scattare la sua risoluzione finale.
La narrazione oscilla tra realismo ed espressionismo e utilizza il tempo cronologico con continui spostamenti tra passato e presente, per caratterizzare la sua mente disturbata. Oltre a usurargli il fisico, la sua vita spesa inseguendo falsi ideali ha corroso anche la sua mente e la sua anima. L’apparente realismo che pervade il testo crea un senso di familiarità con la vita privata dei personaggi che assumono una valenza universale rispecchiando problematiche, sentimenti, emozioni, comuni a tutti gli esseri umani. L’influenza del cinema nel teatro di Miller è evidenziata dallo specifico uso di tecniche narrative prevalentemente visive (uso dei flashback, delle luci, della musica).
Diamo infine, per concludere, un breve sguardo ai personaggi: Linda, coscienza critica del testo, paziente e amorevole moglie del protagonista, partecipe del dramma del marito, avverte che sta pensando di suicidarsi e tenta di spingere i figli ad aiutarlo impedendo la tragedia. Happy è l’emblema del conformismo acritico e standardizzato, omologato. Vede nel conformismo l’unica via per affrontare la lotta per la sopravvivenza, e tenta di tramandarlo anche ai suoi figli e facendo anche di loro dei “prodotti in serie”, gli stessi prodotti che ha sempre venduto. Biff emblema della ribellione senza logica, che lo spinge alla cleptomania. Ben caricatura del “self made man”. Charley filantropo saccente che non stima Willy, ma lo aiuta per pietà e per sentirsi migliore. (Il rifiuto di Willy di accettare il suo aiuto è il suo ultimo risveglio di dignità). Willy ha sempre tenuto un registro dei sui debiti e non vuole elemosina ma giustizia. Howard Wagner spietato, indifferente, egoista, imprenditore sterile figura apparentemente realizzata e vincente ma dietro la maschera del potere e dell’efficienza nasconde una disumanità, che ne fa un arido burattino in una pantomima crudele e vuota di ogni significato. Le voci registrate dei suoi cari danno un senso di quanto i suoi legami siano vuoti e privi di senso.
Arthur Miller nacque a New York nel 1915 da una famiglia d’origine austriaca. Studiò giornalismo all’università del Michigan e iniziò a scrivere testi per la radio, racconti e cronache di guerra. Inseguito si dedicò al teatro vincendo il premio Pulizer per “Morte di un commesso viaggiatore”. E’ morto nel 2005.
Source: libro preso in biblioteca.
Disclosure: questo post contiene affiliate link di Libreriauniversitaria.



 “Hai presente-dici- quando si fanno le scale? I piedi vanno l’uno dietro l’altro così come abbiamo imparato da bambini. Ma la gioia dei primi passi s’è persa. […] Le gambe ora vanno su in base ad abitudini acquisite. E la tensione, l’emozione, la felicità del passo sono andate perdute come anche la singolarità dell’andatura. Ci muoviamo credendo che il movimento delle gambe sia nostro, ma non è così, con noi fa quei gradini una piccola folla cui ci siamo adeguati, la sicurezza delle gambe è solo il risultato del nostro conformismo. O si cambia passo- concludi- ritrovando la gioia degli inizi o ci si condanna alla normalità più grigia.”
“Hai presente-dici- quando si fanno le scale? I piedi vanno l’uno dietro l’altro così come abbiamo imparato da bambini. Ma la gioia dei primi passi s’è persa. […] Le gambe ora vanno su in base ad abitudini acquisite. E la tensione, l’emozione, la felicità del passo sono andate perdute come anche la singolarità dell’andatura. Ci muoviamo credendo che il movimento delle gambe sia nostro, ma non è così, con noi fa quei gradini una piccola folla cui ci siamo adeguati, la sicurezza delle gambe è solo il risultato del nostro conformismo. O si cambia passo- concludi- ritrovando la gioia degli inizi o ci si condanna alla normalità più grigia.” Chiù luntano me stai, chiù vicino te sento;
Chiù luntano me stai, chiù vicino te sento;


 La sua famiglia, che è tutto il suo mondo, è composta, oltre che dalla moglie, da due figli: Happy che presto si sposerà sicuramente avviato a ripercorrere i suoi errori, e Biff che nel tentativo di affermare la sua identità e la sua scala di valori è riuscito solo a diventare un ladro per reazione, non trovando niente di veramente positivo oltre alla ribellione da contrapporre ai valori paterni.
La sua famiglia, che è tutto il suo mondo, è composta, oltre che dalla moglie, da due figli: Happy che presto si sposerà sicuramente avviato a ripercorrere i suoi errori, e Biff che nel tentativo di affermare la sua identità e la sua scala di valori è riuscito solo a diventare un ladro per reazione, non trovando niente di veramente positivo oltre alla ribellione da contrapporre ai valori paterni. Ella portava un braccialetto strano:
Ella portava un braccialetto strano: Storia criminale, realistica e violenta, retta da un flusso interminabile di dialoghi e quasi totalmente priva di descrizioni di ambienti o personaggi, fatta eccezione forse per le scene della rapina alla bisca, del pestaggio di Trattman, o dell’arresto di Russell da parte della narcotici, Cogan (Cogan’s Trade, 1974) del procuratore distrettuale del Massachussetts prestato alla letteratura George V. Higgins, già autore del ben più celebre Gli amici di Eddy Coyle, tradotto per Einaudi da Cristiana Mennella a cui è toccato il difficilissimo e oserei dire improbo compito di rendere in italiano il linguaggio gergale della malavita bostoniana degli anni 70, è un romanzo narrato in terza persona, in cui si alternano le voci dei personaggi che di volta in volta accrescono il tessuto narrativo facendo cambiare prospettiva e profondità all’azione e dando vita ad un quadro di insieme sempre più focalizzato.
Storia criminale, realistica e violenta, retta da un flusso interminabile di dialoghi e quasi totalmente priva di descrizioni di ambienti o personaggi, fatta eccezione forse per le scene della rapina alla bisca, del pestaggio di Trattman, o dell’arresto di Russell da parte della narcotici, Cogan (Cogan’s Trade, 1974) del procuratore distrettuale del Massachussetts prestato alla letteratura George V. Higgins, già autore del ben più celebre Gli amici di Eddy Coyle, tradotto per Einaudi da Cristiana Mennella a cui è toccato il difficilissimo e oserei dire improbo compito di rendere in italiano il linguaggio gergale della malavita bostoniana degli anni 70, è un romanzo narrato in terza persona, in cui si alternano le voci dei personaggi che di volta in volta accrescono il tessuto narrativo facendo cambiare prospettiva e profondità all’azione e dando vita ad un quadro di insieme sempre più focalizzato.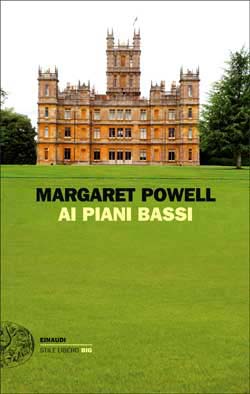 Prima dello sceneggiato televisivo inglese girato tra il 1971 e il 1975 Upstairs, Downstairs, molto prima di Gosford Park e di Downton Abbey uscì in Gran Bretagna, nel 1968, un libro di memorie scritto da una cuoca di nome Margaret Langley Powell, dal titolo emblematico Ai piani bassi (Below Stairs, 1968).
Prima dello sceneggiato televisivo inglese girato tra il 1971 e il 1975 Upstairs, Downstairs, molto prima di Gosford Park e di Downton Abbey uscì in Gran Bretagna, nel 1968, un libro di memorie scritto da una cuoca di nome Margaret Langley Powell, dal titolo emblematico Ai piani bassi (Below Stairs, 1968). 


























