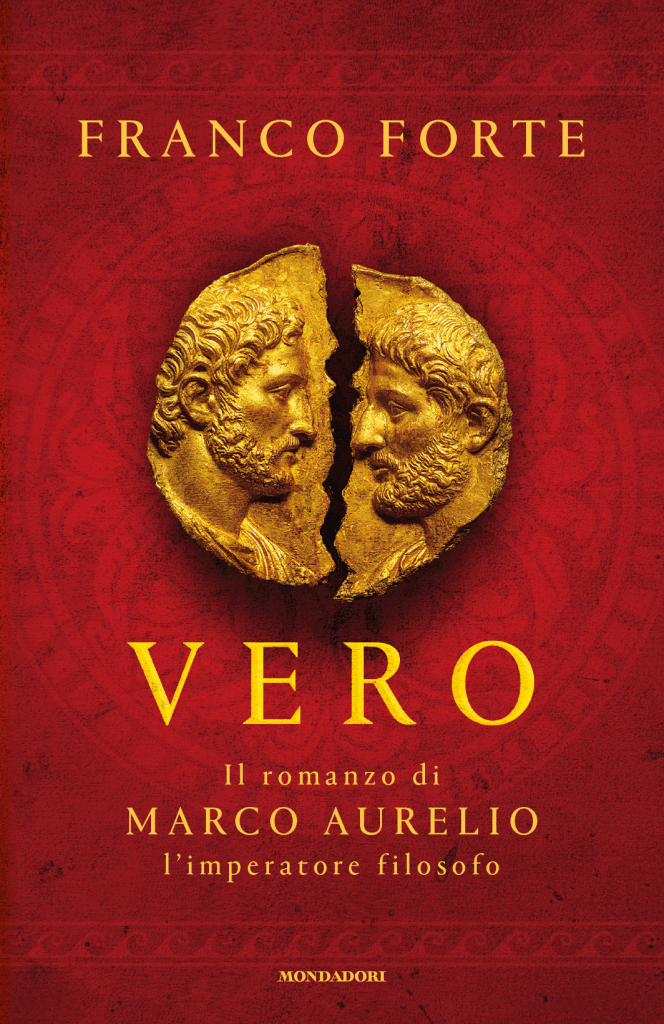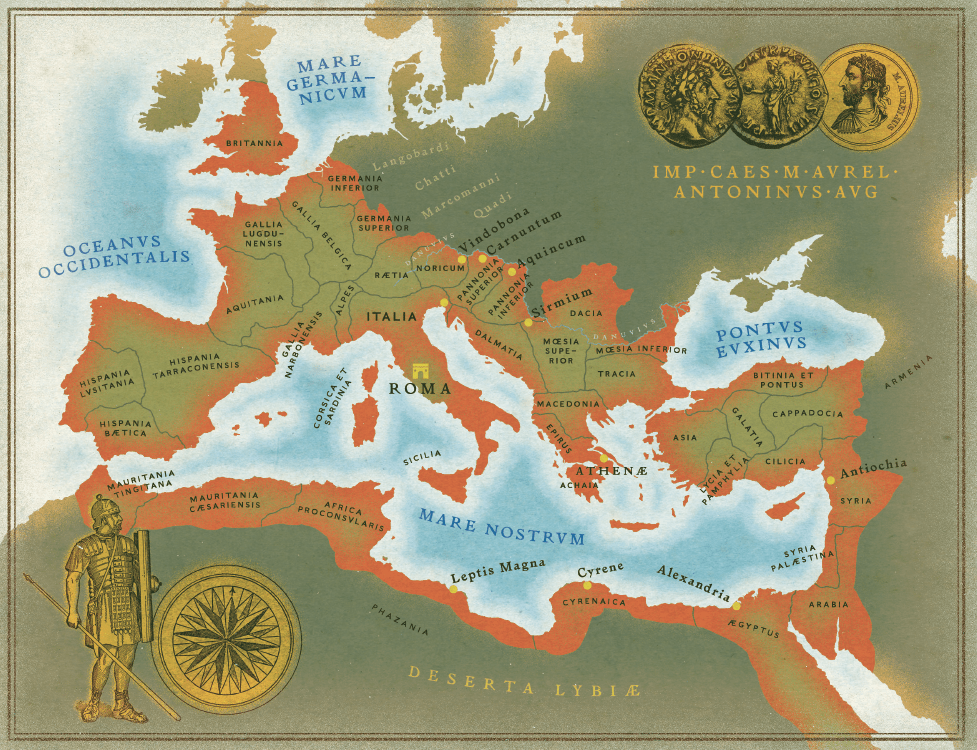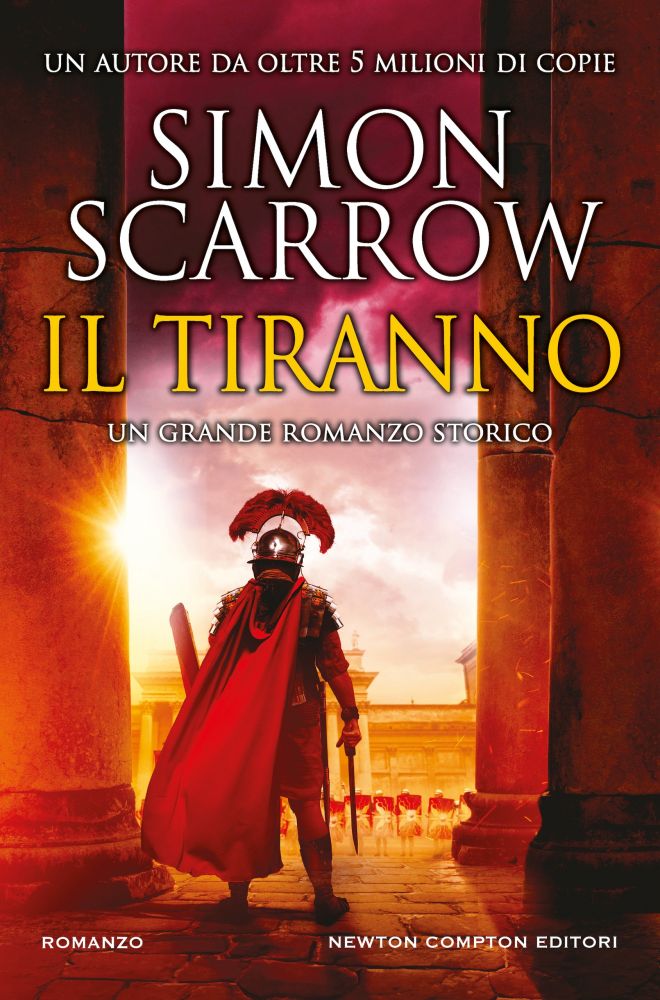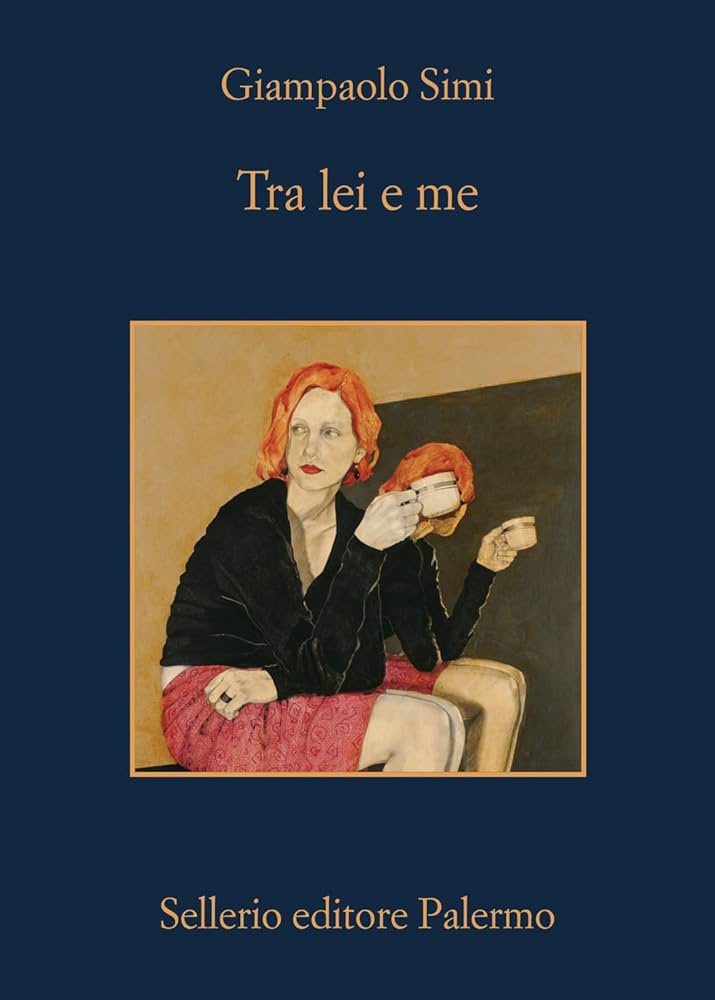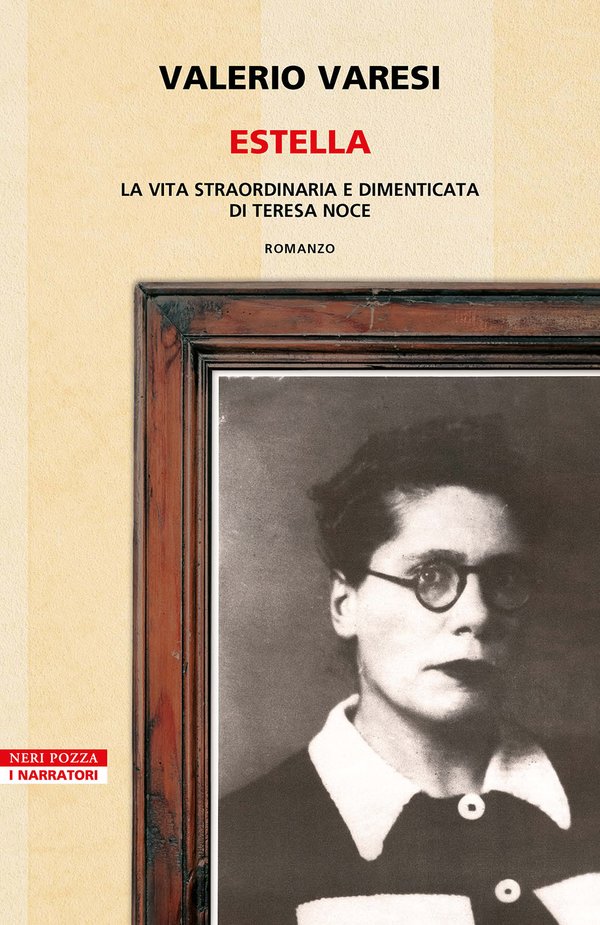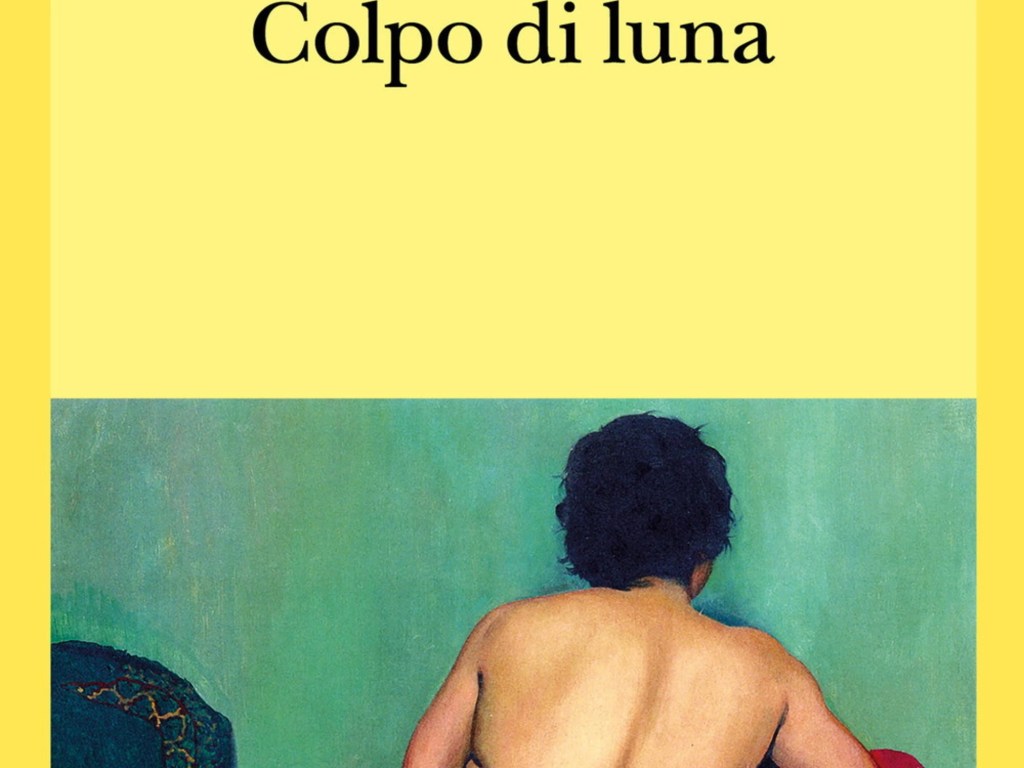Nel 1938 il regime fascista introdusse in Italia una serie di provvedimenti “In difesa della razza” che colpirono drammaticamente tutti gli ebrei del regno. I cittadini ebrei furono cacciati dalle scuole, dalle università, dall’esercito e dal pubblico impiego, mentre un’infinità di disposizioni vessatorie rendeva la loro vita impossibile in ogni campo. Persero il lavoro, e con esso la sicurezza di un dignitoso sostentamento. Coloro che possedevano aziende o terreni se ne videro spogliati. Furono proibiti anche i matrimoni misti.
Una cosa da niente di Mario Pacifici è una testimonianza essenziale e potentissima, che trova nella sua apparente semplicità la forza più profonda. Il titolo stesso racchiude il cuore del libro: l’orrore della persecuzione nazifascista e della Shoah non nasce solo da grandi gesti eclatanti, ma da una somma di atti minimi, di decisioni “normali”, di indifferenze e obbedienze quotidiane che, una dopo l’altra, rendono possibile l’irreparabile.
Pacifici racconta in dodici racconti avvenimenti minimi e fragili con una scrittura sobria, priva di retorica e di compiacimento emotivo. È una scelta stilistica eticamente forte: l’autore non cerca di scioccare il lettore, ma di accompagnarlo dentro una realtà che si svela proprio nella sua disarmante normalità. Le leggi razziali, l’esclusione progressiva dalla vita civile, la paura che diventa abitudine, fino alla deportazione e al lager, sono narrate come tappe di un processo graduale, quasi “logico”, ed è proprio questo che inquieta di più.
Il valore del libro, in relazione alla Giornata della Memoria, sta nella sua capacità di spostare lo sguardo dalla dimensione astratta della Storia a quella concreta delle responsabilità individuali. Pacifici mostra come la violenza non sia opera di mostri isolati, ma il risultato di una società che accetta, giustifica, minimizza. “Una cosa da niente” è ciò che si dice per tranquillizzarsi, per non prendere posizione, per non sentire il peso morale delle proprie azioni – o delle proprie omissioni.
Altro elemento centrale è il rapporto tra memoria e parola. Pacifici scrive non per vendetta né per autoassoluzione, ma per dovere civile. La sua testimonianza è un atto di resistenza contro l’oblio e contro ogni forma di negazionismo o banalizzazione del passato. In questo senso, il libro non si rivolge solo al passato, ma interpella direttamente il presente: ci chiede di riconoscere i segnali, di non considerare mai “da niente” una discriminazione, un linguaggio d’odio, una rinuncia ai diritti altrui.
In conclusione, Una cosa da niente è un’opera di grande valore morale e pedagogico. La sua forza non sta nell’enfasi, ma nella misura; non nell’eccezionalità del racconto, ma nella sua terribile normalità. Leggerlo in occasione della Giornata della Memoria significa accettare una sfida: non limitarsi a ricordare le vittime, ma interrogarsi sul proprio ruolo di cittadini, oggi, davanti alle ingiustizie che ancora nascono – troppo spesso – da “una cosa da niente”.
Mario Pacifici si è avvicinato alla scrittura nel 2008, vincendo con un racconto sulle leggi razziali il concorso indetto dal Festival della Letteratura Ebraica. Nel 2012 è uscita la sua prima raccolta di scritti brevi Una cosa da niente e altri racconti e nel 2015 Daniel il Matto. Con Gallucci, ha già pubblicato i romanzi storici La pedina e Rachele e Giuditta e l’albo La porta aperta con le illustrazioni di Lorenzo Terranera e dedicato alla storia vera di Ferdinando Natoni, Giusto tra le Nazioni che la mattina del 16 ottobre 1943 trasse in salvo Marina e Mirella Limentani.