Dopo la bellissima trilogia di Grouse County Tom Drury continua a illuminare angoli perduti d’America con la sua prosa limpida e partecipe. Il movimento delle foglie racconta la storia di Pierre Hunter, giovane barista con qualche talento musicale (suona la batteria e il violoncello, a dimostrazione del fatto che gli abbinamenti banali non fanno per lui) e abita in una regione del Midwest chiamata Driftless Area, un luogo la cui superficie geologica è costellata di burroni, canyon e foreste. Non è un particolare secondario perché, oltre a occupare la copertina dell’edizione americana in quanto titolo originale, questa Driftless Area, con la sua geografia inospitale gioca un ruolo decisivo nella vicenda terrena di Pierre. Se dico vicenda terrena è perchè questa volta Drury tenta un affondo ulteriore. A differenza del ciclo di Grouse County, tenacemente realista, Il movimento delle foglie ci porta in territori che flirtano col sovrannaturale. Sarebbe sbagliato però, inquadrare questo romanzo, gentile ma implacabile, come una storia dai risvolti horror. A tratti, Il movimento delle foglie, mi ha richiamato alla mente il capolavoro di Frank Capra, La vita è meravigliosa, per la capacità di aprire un punto di osservazione sulla vita degli uomini partendo dalla loro morte, facendo epica di quel complesso meccanismo di più o meno meditate scelte e false piste che spesso sembra essere l’esistenza. Il movimento delle foglie inanella senza un ordine preciso pezzi della vita di Pierre Hunter, la sua storia d’amore con la bellissima ed enigmatica Stella Rosmarin e, una volta scelto il focus del racconto, si concede una deriva crime che scuote le giornate di un ragazzo qualunque come Pierre, un ragazzo nel quale identificarsi è davvero molto facile.
Prima ancora del cosa si mette in scena, in Drury diventa importantissimo il come. Scrittore tenero e anarchico, innamoratissimo dei suoi personaggi, Drury illumina il personaggio di Pierre attraverso la descrizione, di volta in volta quasi impressionistica poi più accurata, di fasi cruciali della sua vita. Si parte con l’adolescenza e il primo amore, per poi riferire di un incidente che agisce da acceleratore per il suo destino. Libro stratificato eppure di cristallina semplicità, Il movimento delle foglie è un anti-manuale di scrittura creativa, idiosincratico e poetico, nel quale Drury si prende tutto il tempo che gli serve per dire ciò che gli preme dire e dà prova di una libertà stilistica senza pari.
Abilissimo nello scolpire il carattere e la fisionomia di una personaggio con due frasi, Drury crea in quest’ultimo romanzo un’altra memorabile galleria di tipi. Non solo Pierre ma anche il suo antagonista Shane Hall, criminale scalcinato e senza sensi di colpa, una versione più dark del Tiny de La fine dei vandalismi, e poi il misterioso Tim Geer, sorta di deus ex machina su cui Drury mantiene un riserbo che è dei grandi narratori, quelli che per comunicare non hanno bisogno di spiegare nulla.
Nota a margine preziosa e prismatica del mondo descritto in Grouse County, Il movimento delle foglie è il segnale della spigliatezza e del coraggio di uno scrittore come Tom Drury, tra i più imprevedibili in circolazione.
 Tom Drury (Iowa 1956) è uno scrittore americano che ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui la fellowship della Fondazione Guggenheim. Dopo aver insegnato nelle università americane, attualmente vive e insegna a Berlino. La fine dei vandalismi, il suo primo romanzo, è uscito negli Stati Uniti nel 1994 ed è stato subito acclamato come miglior libro dell’anno dalle maggiori testate americane.
Tom Drury (Iowa 1956) è uno scrittore americano che ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui la fellowship della Fondazione Guggenheim. Dopo aver insegnato nelle università americane, attualmente vive e insegna a Berlino. La fine dei vandalismi, il suo primo romanzo, è uscito negli Stati Uniti nel 1994 ed è stato subito acclamato come miglior libro dell’anno dalle maggiori testate americane.
Uscito a puntate sul New Yorker, ha ricevuto il premio come Notable Book dell’Ala, l’associazione delle biblioteche americane.
NN Editore ha pubblicato anche gli altri due volumi della trilogia ambientata a Grouse County: A caccia nei sogni e Pacifico; nel corso dei prossimi anni pubblicherà la sua intera opera.
Source: libro inviato dall’ editore al recensore. Ringraziamo Francesca Rodella ufficio stampa dedicato.
Disclosure: questo post contiene affiliate link di Libreriauniversitaria.

 “Mio padre non si sbagliava di molto, poiché una grossa fetta di responsabilità nei confronti dell’infelicità di mia madre era davvero mia, ma dubito del fatto che si preoccupasse veramente della salute della moglie. Per lui quella era semplicemente una cosa sua e l’aveva scelta apposta perché lo servisse senza disturbare. Anche lei avrà avuto i suoi motivi per prenderselo e tenerselo, insomma non c’era alcuna ragione per dubitare che non fossero reciprocamente soddisfatti del loro rapporto. Perlomeno questo è quello che mi sento di affermare oggi in base ai miei ricordi. Ecco, adesso posso dire di aver completamente sviscerato l’argomento.”
“Mio padre non si sbagliava di molto, poiché una grossa fetta di responsabilità nei confronti dell’infelicità di mia madre era davvero mia, ma dubito del fatto che si preoccupasse veramente della salute della moglie. Per lui quella era semplicemente una cosa sua e l’aveva scelta apposta perché lo servisse senza disturbare. Anche lei avrà avuto i suoi motivi per prenderselo e tenerselo, insomma non c’era alcuna ragione per dubitare che non fossero reciprocamente soddisfatti del loro rapporto. Perlomeno questo è quello che mi sento di affermare oggi in base ai miei ricordi. Ecco, adesso posso dire di aver completamente sviscerato l’argomento.” Il buio a luci accese è il libro d’esordio dell’irlandese David Hayden. Ora, grazie all’editore Safarà al quale dobbiamo proposte e recuperi non meno eccentrici (dal classico contemporaneo Alasdair Gray all’americana Helen Phillips), il libro è disponibile anche per noi lettori dello stivale.
Il buio a luci accese è il libro d’esordio dell’irlandese David Hayden. Ora, grazie all’editore Safarà al quale dobbiamo proposte e recuperi non meno eccentrici (dal classico contemporaneo Alasdair Gray all’americana Helen Phillips), il libro è disponibile anche per noi lettori dello stivale.


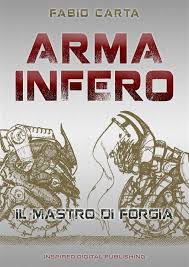 L’interessante libro di Fabio Carta ha forse il solo torto di chiudere con un finale decisamente aperto ma è un torto molto relativo, nel senso che appare tale solo a chi non ha dimestichezza con le saghe fantasy, quasi sempre declinate in trilogie se non in serie di volumi ancora più corposi (chi scrive, ahimé, appartiene alla categoria). A parte questo, ci troviamo di fronte a un perfetto meccanismo narrativo e spettacolare, ponderoso nella sostanza e austero nella forma.
L’interessante libro di Fabio Carta ha forse il solo torto di chiudere con un finale decisamente aperto ma è un torto molto relativo, nel senso che appare tale solo a chi non ha dimestichezza con le saghe fantasy, quasi sempre declinate in trilogie se non in serie di volumi ancora più corposi (chi scrive, ahimé, appartiene alla categoria). A parte questo, ci troviamo di fronte a un perfetto meccanismo narrativo e spettacolare, ponderoso nella sostanza e austero nella forma. Johnny Stompanato è una delle tante figure, probabilmente nemmeno la più bizzarra o carismatica, apparsa nella Hollywood-Babilonia del secondo dopoguerra e prismaticamente riscritta in decenni di mitologie e narrazioni, a malapena una comparsa nei romanzi losangelini di James Ellroy e lontana ispirazione per opere tra loro diversissime (un riferimento, seppure molto sfumato, ai fatti di Stompanato e Turner è contenuto anche nel film Settembre di Woody Allen).
Johnny Stompanato è una delle tante figure, probabilmente nemmeno la più bizzarra o carismatica, apparsa nella Hollywood-Babilonia del secondo dopoguerra e prismaticamente riscritta in decenni di mitologie e narrazioni, a malapena una comparsa nei romanzi losangelini di James Ellroy e lontana ispirazione per opere tra loro diversissime (un riferimento, seppure molto sfumato, ai fatti di Stompanato e Turner è contenuto anche nel film Settembre di Woody Allen).
 Il secondo romanzo di Edoardo Zambelli (l’autore ha al suo attivo L’antagonista, uscito un paio d’anni fa sempre per Laurana) ha un titolo, Storia di due donne e uno specchio, che, se vogliamo, pone la sua storia nel segno dell’evidenza, anche se poi tutto all’interno di questo libro si rivela duplice e aperto alle più diverse interpretazioni. D’altra parte lo specchio è uno strumento che raddoppia la nostra immagine, nonché quella degli oggetti che ci stanno intorno. Le due donne evocate dal titolo, Alessandra e Marta, vengono inquadrate in un momento decisivo della loro esistenza e la loro vicenda spezzata in due tempi che sono anche le parti di cui il testo è composto. Alessandra e Marta si conoscono a un funerale, diventano amiche, poi diventano amanti. Alessandra torna in Veneto dopo una lunga permanenza in Puglia, deve riannodare i fili con quel poco che è rimasto della sua famiglia, vale a dire un padre malato di Alzheimer. Per Marta le cose sono forse addirittura più complicate perché la sua routine viene sconvolta da un uomo, Ethan, che sembra sapere cose del suo passato che nemmeno lei conosce. Di più ancora: Ethan vuole ricondurla a quel passato, pressandola con un’azione di stalking che sembra preludere a qualcosa di tremendo. Poi la storia si azzera e si ricomincia. Marta e Alessandra (è la stessa Marta ma non la stessa Alessandra, ma potrebbe anche non essere così) sono madre e figlia. Marta adesso ha diciott’anni e andiamo con lei a esplorare quel passato negato e riportato alla luce della propria coscienza nella prima parte, senonché il talento tentacolare di Zambelli costringe le esistenze dei suoi personaggi a una torsione su se stesse, quasi a volerle mostrare attraverso un prisma che insieme cela e illumina. Storia di due donne e uno specchio sembra aggiornare l’Hitchcock de La donna che visse due volte (anche qui del resto c’è una Judy) e corteggia da vicino il Lynch più estremista, quello di Strade perdute e Mulholland drive, ma se faccio riferimenti cinematografici è solo per comodità (e forse pigrizia) dal momento che il romanzo di Zambelli onora il medium che si è scelto senza sensi di colpa o complessi di inferiorità, anzi. La lingua dell’autore è densissima e consapevole, capace di assediarci coi suoi misteri restando piana, trasparente e questo rende ancora più oscuro e traumatico il labirinto costruito intorno al lettore.
Il secondo romanzo di Edoardo Zambelli (l’autore ha al suo attivo L’antagonista, uscito un paio d’anni fa sempre per Laurana) ha un titolo, Storia di due donne e uno specchio, che, se vogliamo, pone la sua storia nel segno dell’evidenza, anche se poi tutto all’interno di questo libro si rivela duplice e aperto alle più diverse interpretazioni. D’altra parte lo specchio è uno strumento che raddoppia la nostra immagine, nonché quella degli oggetti che ci stanno intorno. Le due donne evocate dal titolo, Alessandra e Marta, vengono inquadrate in un momento decisivo della loro esistenza e la loro vicenda spezzata in due tempi che sono anche le parti di cui il testo è composto. Alessandra e Marta si conoscono a un funerale, diventano amiche, poi diventano amanti. Alessandra torna in Veneto dopo una lunga permanenza in Puglia, deve riannodare i fili con quel poco che è rimasto della sua famiglia, vale a dire un padre malato di Alzheimer. Per Marta le cose sono forse addirittura più complicate perché la sua routine viene sconvolta da un uomo, Ethan, che sembra sapere cose del suo passato che nemmeno lei conosce. Di più ancora: Ethan vuole ricondurla a quel passato, pressandola con un’azione di stalking che sembra preludere a qualcosa di tremendo. Poi la storia si azzera e si ricomincia. Marta e Alessandra (è la stessa Marta ma non la stessa Alessandra, ma potrebbe anche non essere così) sono madre e figlia. Marta adesso ha diciott’anni e andiamo con lei a esplorare quel passato negato e riportato alla luce della propria coscienza nella prima parte, senonché il talento tentacolare di Zambelli costringe le esistenze dei suoi personaggi a una torsione su se stesse, quasi a volerle mostrare attraverso un prisma che insieme cela e illumina. Storia di due donne e uno specchio sembra aggiornare l’Hitchcock de La donna che visse due volte (anche qui del resto c’è una Judy) e corteggia da vicino il Lynch più estremista, quello di Strade perdute e Mulholland drive, ma se faccio riferimenti cinematografici è solo per comodità (e forse pigrizia) dal momento che il romanzo di Zambelli onora il medium che si è scelto senza sensi di colpa o complessi di inferiorità, anzi. La lingua dell’autore è densissima e consapevole, capace di assediarci coi suoi misteri restando piana, trasparente e questo rende ancora più oscuro e traumatico il labirinto costruito intorno al lettore. NN editore ci sta abituando molto bene con la continua proposta di narratori americani, sconosciuti nelle nostre contrade. Dopo i pesi massimi Kent Haruf e Tom Drury, per non parlare della più giovane ma non meno straordinaria Jesmyn Ward, è ora la volta di James Anderson con il suo romanzo d’esordio Il diner nel deserto. Probabilmente Anderson è, tra i nomi del lotto, il più incline a tentazioni di genere (lasciamo fuori l’ottimo Brian Panowich, per il cui il noir è ben più che una tentazione). In ogni caso Il diner nel deserto è un romanzo che, inserendosi nei panorami on the road di tanta celebre e celebrata letteratura americana, riesce a trovare indubbie zone di originalità.
NN editore ci sta abituando molto bene con la continua proposta di narratori americani, sconosciuti nelle nostre contrade. Dopo i pesi massimi Kent Haruf e Tom Drury, per non parlare della più giovane ma non meno straordinaria Jesmyn Ward, è ora la volta di James Anderson con il suo romanzo d’esordio Il diner nel deserto. Probabilmente Anderson è, tra i nomi del lotto, il più incline a tentazioni di genere (lasciamo fuori l’ottimo Brian Panowich, per il cui il noir è ben più che una tentazione). In ogni caso Il diner nel deserto è un romanzo che, inserendosi nei panorami on the road di tanta celebre e celebrata letteratura americana, riesce a trovare indubbie zone di originalità. “Il treno ripartì proprio in quel momento. Con la coda dell’occhio lo vidi sfilare, lento e poi più veloce e non capii cosa, esattamente cosa, ma a bordo di quel treno lasciammo molte cose, tutto, probabilmente tutto quello che c’era stato e quello che sarebbe potuto essere.”
“Il treno ripartì proprio in quel momento. Con la coda dell’occhio lo vidi sfilare, lento e poi più veloce e non capii cosa, esattamente cosa, ma a bordo di quel treno lasciammo molte cose, tutto, probabilmente tutto quello che c’era stato e quello che sarebbe potuto essere.”
























