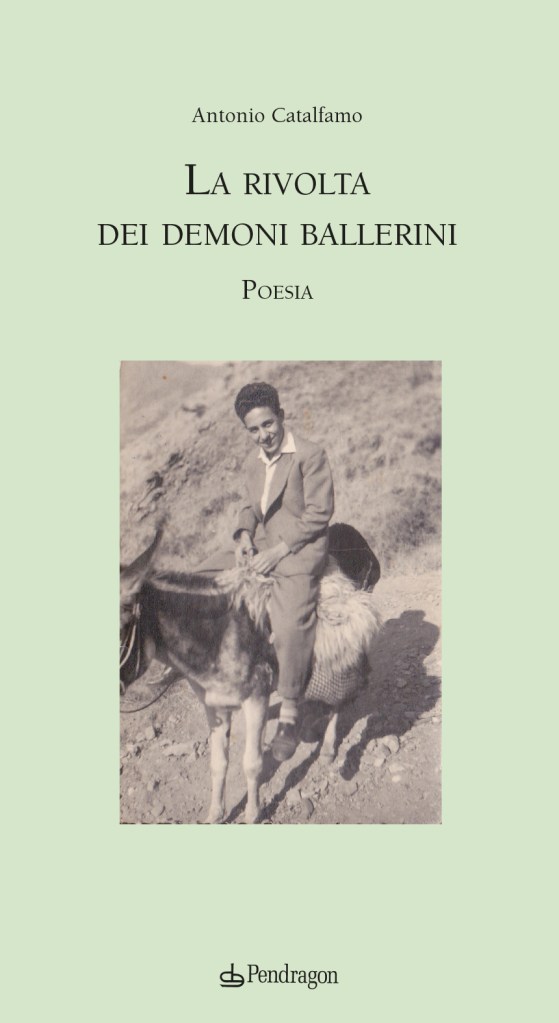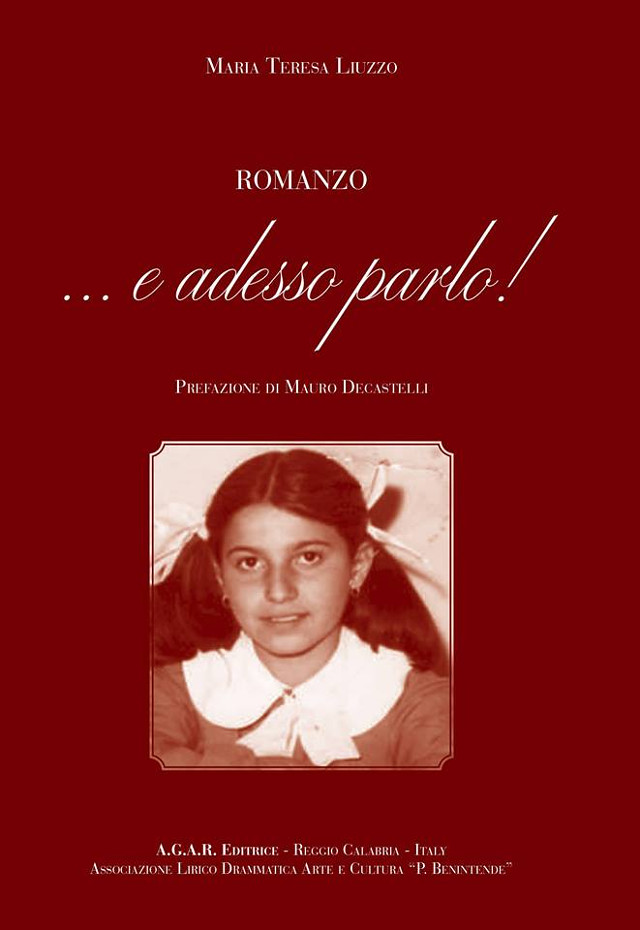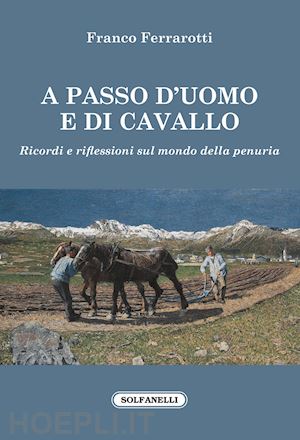Maria Teresa Liuzzo completa con L’ombra affamata della madre (A.G.A.R. Editrice, Reggio Calabria, 2022) la «trilogia» programmata di romanzi, di cui i due precedenti volumi sono: … E adesso parlo! (ibidem, 2019); Non dirmi che ho amato il vento! (ibidem, 2021). Chi, avendo letto i precedenti romanzi, si aspettasse che il terzo si ponesse in linea di continuità rimarrebbe deluso, perché esso è dominato da un’ “aura” nuova, da uno sperimentalismo non convenzionale, che ne fa un “unicum” nella produzione della scrittrice, sia a livello formale che contenutistico. Né, d’altra parte, Maria Teresa Liuzzo ripropone pedissequamente modelli altrui, ormai consolidati, che si ispirano al «monologo interiore», al «flusso di coscienza», che rimandano a scrittori di valore come James Joyce e che sono stati ripresentati al pubblico dei lettori in mille salse, fino a diventare stucchevoli, pur nella loro pretesa perfezione formale. La nostra autrice batte sempre strade nuove, rischiando l’«imperfezione», che è un pregio, non un difetto. Leonardo Sciascia, con il suo consueto acume critico, ha sottolineato, nelle noterelle di Nero su nero, che «la perfezione sta alla cretineria meglio che all’intelligenza; l’intelligenza ha sempre, come i tessuti dei navajos una qualche imperfezione o fuga». I rifacitori pedissequi di modelli altrui sono «perfetti» imitatori, paragonabili alle scimmie, secondo Sciascia: «Se una scimmia si mettesse a battere sui tasti di una macchina da scrivere, alla fine verrebbe fuori un sonetto di Shakespeare (variante: dodici scimmie, tutti i libri del Museo Britannico)». Un impegno degno di miglior causa, il loro.
Maria Teresa Liuzzo, invece, affronta il mare aperto, con tutti i pericoli ch’esso nasconde. E così, in questo terzo romanzo («sperimentale», dicevamo), il lettore cercherà invano un «intreccio» ben definito, corrispondente, con tutti gli espedienti consolidati della «narratologia», ad una «fabula». Troverà, per converso, un flusso di immagini, di pensieri, di allucinazioni, che si accavallano nella mente della protagonista, Mary, che sembrano slegati l’uno dall’altro, ma hanno come trait d’union tra di loro, ma anche con i due romanzi precedenti, la cieca violenza sulla donna.
L’amore di Mary e di Raf è contrastato, contraddittorio. Ha momenti di passione molto intensa. I due amanti si sciolgono nella natura, i loro corpi si intrecciano, si sovrappongono. E’ forte la tensione poetica, che ricorda La pioggia nel pineto di Gabriele D’Annunzio, poesia contenuta nella raccolta Alcyone, dalla quale emerge il poeta autentico, libero dall’influenza nefasta del «superomismo», fra l’altro recepito in una versione indiretta, distorta, rispetto all’interpretazione originale di Nietzsche, allora conosciuta attraverso la mediazione francese. Il migliore D’Annunzio è il «notturno», nel quale la malattia determina un ripiegamento su se stesso, sul proprio «io», una riflessione pacata sull’esistenza umana, libera, per l’appunto, dai furori «superomistici». Altra cosa è il D’Annunzio de Il piacere, o, addirittura, de Il fuoco, in cui prevalgono gli eccessi dell’amore esclusivamente carnale, ridotto a puro eros.
Maria Teresa Liuzzo ripropone, invece, la dimensione “panica” de La pioggia nel pineto. Basta leggere qualche pagina intensamente poetica (p. 60): «Raf e Mary avevano guardato i rami pieni di linfa mettere le prime foglie, nuove e delicate, lucide e zuccherine, e ora appassire gli ultimi fiori. Sbocciavano ancora le ombre tombali dei crisantemi. Il balcone era pieno di sole settembrino. Raf passò la mano lungo i fianchi di Mary: tutto il suo corpo era il suo cuore. Ma era l’epoca in cui il dolce tempo estivo declina e ritorna il verno a inaridire i campi e i cuori. I passeri si beccavano disperdendosi sulla prima neve e Mary, liberata la tenda, attraverso la persiana socchiusa, seguiva i loro voli e le loro scalmane. Il vento portava folate d’erica, i giorni si abbandonavano al freddo crescente come braccia stanche. D’acquerelli di fuoco dipinte, loro le piogge contemplavano danzare / sulle aride bocche scarlatte e sulla corteccia dei salici brillare. Era già ieri il volo alto delle gru sul panno verde del mare; attraverso i giunchi il sole e la tempesta non temevano il divenire affannoso della vita, usciva fumo dai tetti addormentati. Il silenzio sbiancava di anime incarnate dentro il gelo, e si sfaldavano friabili cristalli nella luce» (ivi, p. 60).
Ma questo amore è tormentato, contraddittorio. Raf da amante si trasforma in aguzzino: «Raf voleva vivere felice finalmente, edificando per Mary un altare d’infelicità. Invero però non aveva alibi per il suo comportamento, a dir poco, miserrimo. Da aguzzino poi voleva trasformarsi in vittima, per meglio convivere con sé stesso, e si sfaldavano friabili cristalli nella luce» (ibidem). Mary allora, contro le brutture della vita, le illusioni tradite, gli amori che si trasformano in sevizie, si abbandona alla poesia, che lei definisce «avversaria» (ivi, p. 89), per dire, antifrasticamente, che è l’unica vera amica e fonte di conforto. Così registriamo versi molto sofferti, come questi: «Oggi sto male e debole si sveglia la parola. / Poggio le labbra sulla mano. Piango. / Piango sui lunghi capelli corvini, / tra un sorso acerbo di luce e un morso di poesia. / Tra suppellettili d’infanzia e un gioco inventato / durato una stagione, forse meno: / qui giaceva la giovinezza con la speranza. // Un angelo copriva il sangue della morte. / Fame – malaffare – esecuzione. / La sofferenza incanalata nel ventre, / passava come un cadavere sul fiume» (ivi, p. 90). E così Mary descrive la funzione salvifica che ha per lei la scrittura, come strumento di denuncia del male che ha subito e continua a subire: «L’avevano salvata dall’angoscia e dalla morte precisamente i gesti ripetuti dell’abitudine alla scrittura, la fatica dello scrivere e il suo pensiero brillante che la fitta nebbia dello straniamento, di colpo, sapeva da parte a parte traversare» (ivi, p. 98). Perciò i suoi scritti sono temuti dai nemici, dagli aguzzini, che vedono in essi un «tradimento», una «delazione», una violazione della cortina di silenzio che protegge chi fa il male impunemente: «Per alcuni il suo particolare modo di raccontare era visto come nient’altro che un tradimento, perché ritenevano la viscerale scrittura di Mary una esplicita forma di provocazione, una lettura per loro piuttosto sulfurea, esiziale, una parola testarda, vendicativa, delatrice nel voler trasgredire e peccare a tutti i costi; ma bellamente tacere lo sarebbe stato persino di più» (ivi, pp. 97-98).
L’ultimo capitolo è dedicato alla figura della madre. La sua è una presenza inquietante nella vita di Mary, che le ha procurato solo dolore. La protagonista del romanzo si abbandona ai ricordi, che rievocano tutto il male e la violenza fisica e morale che ha subito dalla madre: «La voce rauca e maledettamente disumana della madre, quando le ordinava di cantare per il padre dopo averla schiaffeggiata, presa a calci e averle chiuso le mani intorno al collo come lo stringersi inesorabile di una corda. Poi le ripeteva compiaciuta: “Canta, canta per tuo padre! Altrimenti seguiranno le scudisciate e canterai ballando… intorno al lupo”. […] Il folle e la sua degna compagna registravano le canzoni che Mary era obbligata a cantare, e le riascoltavano dentro e fuori casa, in auto quando andavano a trovare Fiamma o quando lui andava a caccia o a lavorare. Morbosità malata – complicità mostruosa» (ivi, p. 115).
Mary perdona tutti quelli che le hanno fatto male nella vita e si incammina verso la morte: «L’amore è come l’acqua, il vento, il mare, non si può imprigionare. In tanti, un giorno mi cercherete, ma non mi troverete. Ricordate soltanto che vi ho molto amato. E che vi ho voluto bene. […] Reclinò il capo, abbandonata sul letto, la mano cadde inerte. A terra la sua foto di bambina, con i codini e gli occhi sommessamente tristi» (ivi, p. 126). E la poesia è presente anche nell’epilogo della sua vita: «Giaceva nei suoi occhi un verso fattosi più terso e lucente, scritto col sangue» (ivi, p. 127). Alcuni versi finali potrebbero esser posti come epigrafe sulla sua tomba a testimoniare la sua «santità» nella sopportazione del dolore: «Aliena da qualsiasi divisione, / integra la materia e non profana / nel suo vivere da Santa essenzialmente» (ibidem).
La violenza che domina questo terzo romanzo della «trilogia» programmata è quella della società semi-feudale della Calabria nella quale Maria Teresa Liuzzo è nata ed è vissuta (e vive ancora), ma è anche quella della società capitalistica attuale, cosiddetta «matura». Una violenza che colpisce la donna, in quanto componente debole (così come i bambini), in quanto il più forte, nel suo delirio di onnipotenza, vede sempre insidiato il suo potere. E l’insidia, in questo caso, viene da una donna apparentemente fragile, Mary, che ha un’arma molto potente: la poesia.
Franco Ferrarotti, con il suo consueto acume critico, ci ha resi edotti circa l’essenzialità della poesia nel mondo attuale, supertecnologico: «In un’epoca come la presente, dominata dalla razionalità formale su cui si fonda la tecnica, dallo spirito politecnico, vale a dire dall’esprit de géométrie a scapito dell’esprit de finesse, per valermi della formula di Blaise Pascal, caratterizzata pertanto dal calcolo scientifico e dall’elettronica applicata, forse non si dà altro rimedio all’inaridimento della vita umana fuor che la poesia» (Le ragioni della poesia nella società irretita, gattomerlino, Roma, 2019, p. 10). E ci ha spiegato qual è il “miracolo” che solo la poesia sa compiere: «Il nostro mondo mi sembra condannato – ma non voglio essere apocalittico, perché in fondo sono un ottimista – per il fatto che considera la poesia una manifestazione accessoria, mentre è la forma più alta di conoscenza, certamente protologica, prelogica, intuitiva, non ripercorribile da chiunque. E’ la straordinaria possibilità di collegare un’esperienza circoscritta, minuta, empirica, anche, se si vuole, miserabile, attraverso la metafora, a un significato universale. La poesia precede il filosofo, precede lo scienziato» (Dialogo sulla poesia, gattomerlino, Roma, 2018, p. 12).
Maria Teresa Liuzzo continua ad essere artefice di questo “miracolo”.