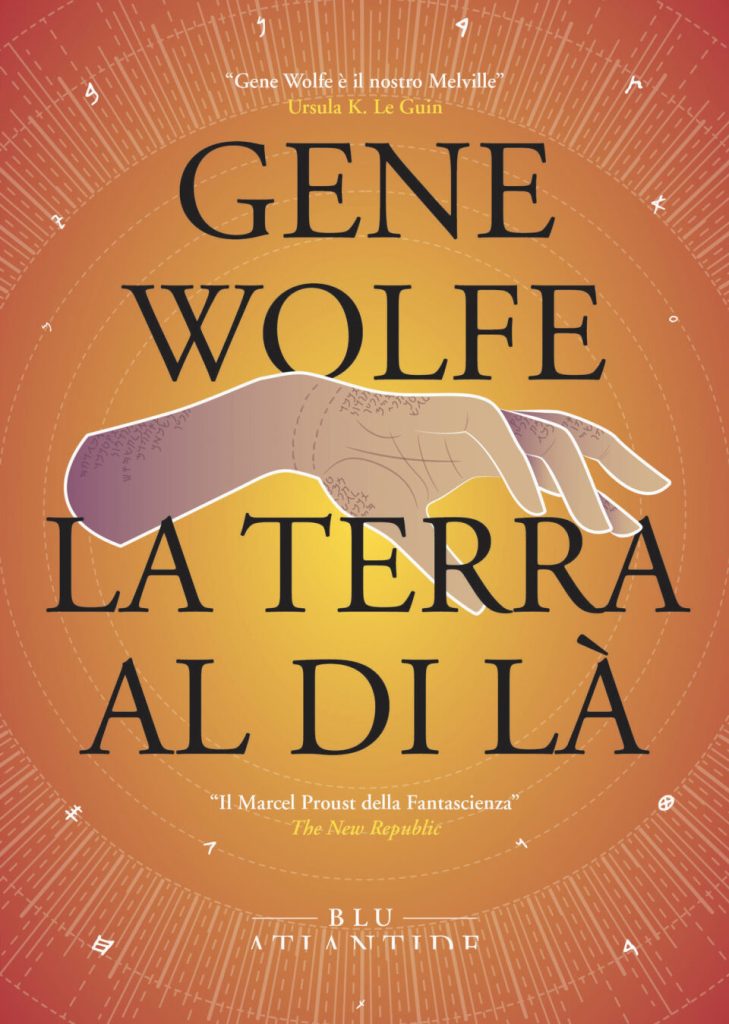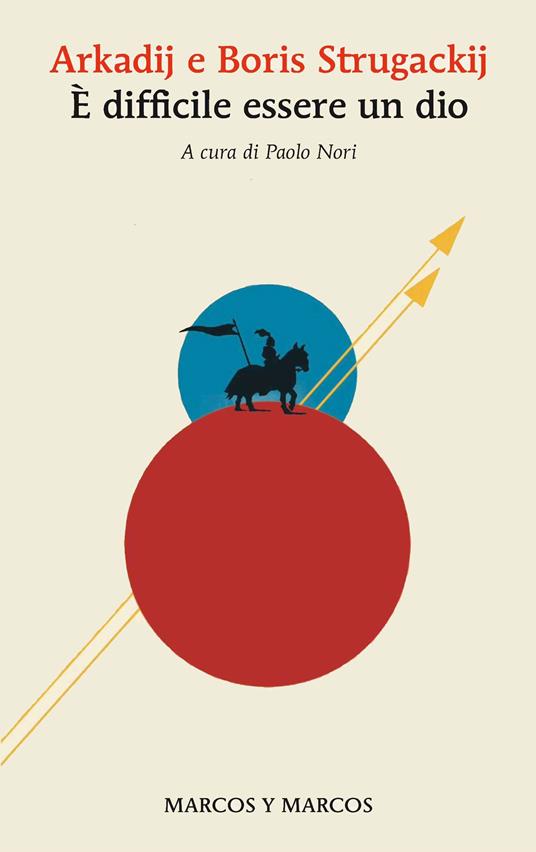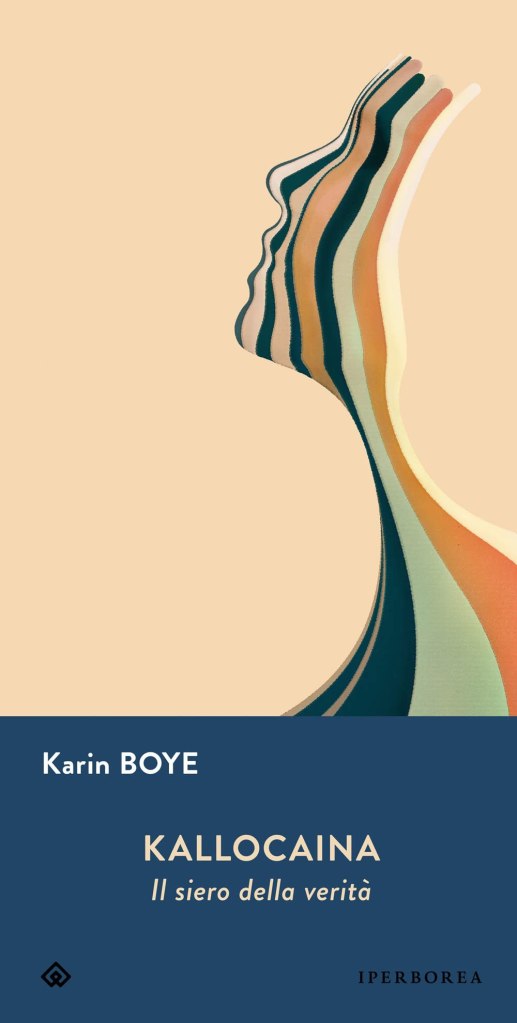The Iron Dragon’s Daughter è uscito in America nel 1993, per poi essere pubblicato come Cuore d’acciaio da Fanucci nel 1995 e con il suo seguito The Dragons of Babel (I draghi di Babele, 2007) per Urania all’interno della raccolta I draghi del ferro e del fuoco (2011). Nel novembre 2024 è stato finalmente ristampato da Mercurio Books, una nuova casa editrice indipendente. L’autore, Michael Swanwick, americano, classe 1950, ha vinto i premi Nebula, Hugo e il World Fantasy Award e ha scritto racconti a quattro mani con William Gibson e Gardner Dozois.
Prima di passare alla recensione mi si permetta una nota su questa nuova edizione. Nel colophon troviamo un trigger warning, ovvero un’avvertenza volta a indicare la presenza di un contenuto che potrebbe urtare la sensibilità dei lettori. Spero che questa pratica politically correct importata dagli Stati Uniti non diventi un’abitudine nell’editoria, e ammetto che trovarla riportata all’interno di un libro mi ha allarmato ben più del presunto elemento perturbante da cui voleva mettermi in guardia. Mi trovo quasi in imbarazzo a dover ribadire che un libro, in quanto veicolo di cultura, non ha alcun bisogno di bollini colorati come i film o di altre insensate misure affini. La traduzione di Susanna Bini qui riproposta a volte inciampa in calchi dall’inglese fin troppo evidenti, ma tutto sommato si lascia leggere con scorrevolezza.
Ciò premesso, veniamo alla trama. Jane Alderberry è una changeling, una bambina umana che nelle leggende viene scambiata nella culla con un figlio delle fate. Jane si ritrova così a vivere nella dura realtà del Mondo delle Fate e a lavorare a ritmi estenuanti in una fabbrica in cui vengono prodotti draghi meccanici. Se l’atmosfera steampunk echeggia la dickensiana Coketown di Tempi difficili (1854), qui troviamo già un aspetto innovativo del romanzo di Swanwick, in cui la figura del drago viene modernizzata traendo ispirazione dal cyberpunk: i draghi sono infatti creature meccaniche e cibernetiche, rivestite di ferro e dotate di circuiti elettrici, che vengono pilotate come caccia militari. Se Ann McCaffrey, con il suo ciclo dei Dragonieri di Pern, aveva inserito i draghi in un’ambientazione fantascientifica, Swanwick è andato ben oltre rendendoli cyberpunk.
Jane entra in contatto con uno dei questi draghi, il più potente e maligno, destinato alla demolizione. Il suo nome, Melanchton, è un chiaro rimando a Filippo Melantone, nome ellenizzato di Philipp Schwarzerdt (1497-1560), teologo amico di Martin Lutero e animatore della Riforma protestante. Il drago Melanchton è una creatura manipolatrice, astuta e subdola, blasfema e nichilista, animata dall’odio e dalla vendetta. Jane e Melanchton stringono un patto e progettano la fuga. Scappata dalla fabbrica, Jane frequenta prima il liceo e poi l’università di alchimia, stringendo nuove amicizie, sperimentando droghe, praticando sesso occasionale e dedicandosi al taccheggio e alle arti magiche. Il suo percorso non è un arco lineare di crescita bensì una continua spirale distruttiva, scandita dagli stessi errori, dalle stesse perdite e dagli stessi sensi di colpa, in cui incarnazioni diverse degli stessi personaggi tornano a rivivere in un eterno ritorno. Non è un caso che all’interno del romanzo si menzioni il nastro di Möbius, la superficie non orientabile descritta dalla topologia matematica che ha ispirato la struttura di alcuni film di David Lynch.
Un’altra innovazione che salta subito all’occhio del lettore è indubbiamente l’ambientazione. Swanwick descrive con capacità immaginativa e abilità creativa apparentemente inesauribili un universo che sovverte sia i canoni dell’high fantasy classico, di matrice tolkieniana, in cui il Mondo Secondario è sub-creazione del Mondo Primario, sia dell’urban fantasy, in cui elementi fantastici vengono trapiantati nel nostro mondo. Si potrebbe parlare di portal fantasy, quel sottogenere in cui un personaggio del nostro mondo si ritrova per qualche ragione catapultato in un mondo altro, ma La figlia del drago di ferro è un romanzo che proprio in virtù della sua natura camaleontica e ibrida sfugge a ogni tentativo di classificazione. Le etichette di science fantasy e di dark fantasy, pur se applicate con una certa ragionevolezza, appaiono riduttive se non eufemistiche. In effetti, la critica specializzata non ha lesinato tentativi di categorizzare di quest’opera con le definizioni più fantasiose e disparate: c’è chi ha parlato di elfpunk, chi di technofantasy, chi di industrial fantasy o ancora chi, come John Clute[1], ha parlato di anti-fantasy per via dell’amoralità dei suoi personaggi e in particolare della sua anti-eroina. Una definizione che potrebbe apparire calzante, ma che è stata rispedita al mittente dallo stesso Swanwick, che nel suo blog ha affermato che «[q]uesto non è mai stato il mio intento»[2]. In un’intervista si è detto «scioccato» dalla definizione di anti-fantasy, perché «amo il fantasy e non stavo certo cercando di demistificarlo»[3].
È anzi proprio l’ibridazione dei generi, unitamente alla complessità del testo, al gusto citazionista e alla tendenza alla decostruzione, che a mio avviso dovrebbe far pensare al carattere postmoderno di questo romanzo sui generis. Il tono oscilla tra il tecnico-scientifico alla Gibson, il colloquiale, il grottesco e il volgare, in una continua commistione di magia e cibernetica, che può essere sintetizzata in sintagmi molto espressivi ideati dall’autore come «cloruro d’ammonio e fegato di rospo» o «cornamuse elfiche e sintetizzatori». Il ricorso a visioni psichedeliche e allucinazioni lisergiche può ricordare Hunther S. Thompson, mentre tra gli scrittori che più hanno influenzato Swanwick troviamo Hope Mirrlees, autrice di Lud nella Nebbia (1926), cui l’autore ha dedicato anche una monografia[4], e naturalmente J.R.R. Tolkien. Il Wall Street Journal ha definito quello creato da Swanwick «l’universo fantastico più accuratamente immaginato dopo quello di J.R.R. Tolkien». Certo, si potrebbe pensare che si tratti di esagerazioni pubblicitarie che lasciano il tempo che trovano e da prendere con le dovute cautele; eppure va detto che Swanwick non appartiene a quel novero di autori che rinnegano Tolkien, non è affetto (come Michael Moorcock e altri) da quel complesso edipico che vorrebbe uccidere il padre putativo del fantasy moderno, ma ha ammesso il debito nei suoi confronti:
«A livello profondo e inconscio, [La figlia del drago di ferro] è una dura critica di ciò che il fantasy è diventato. Mi sono innamorato del fantasy al liceo, e ho letto La compagnia dell’anello nel corso di una lunga nottata. Finii i miei compiti alle 11 di sera, e lo aprii, pensando di leggere un capitolo o due prima di addormentarmi, e finii l’ultima pagina proprio quando suonò la campanella dell’appello nel mio liceo la mattina dopo. Dopodiché cercai e lessi tutti i grandi autori fantasy – E.R. Eddison, Mervyn Peake, Fritz Leiber, Hope Mirrlees, Amos Tutuola, e così via. Perciò la recente ondata di trilogie fantasy intercambiabili mi ha scosso quasi allo stesso modo della scoperta che i boschi in cui ero solito giocare da bambino sono stati rasi al suolo per fare spazio a mediocri complessi residenziali»[5]
Benché a mio avviso si sia lontani dalle vette letterarie e artistiche di quell’immortale capolavoro che è Il Signore degli Anelli, è possibile tracciare alcuni punti di contatto tra le due opere. Per esempio, si può notare come Swanwick mutui dall’opus magnum tolkieniano il tema della quest, volta non già alla distruzione di un artefatto magico, bensì alla distruzione dell’universo stesso e alla morte di Dio (anzi, della Dea). Parimenti tolkieniani sono l’importanza che i nomi rivestono all’interno dei due romanzi, e come la conoscenza dei veri nomi delle cose consenta di avere potere su di esse, o ancora si potrebbe vedere nella fuga di Jane dalla sua realtà un parallelo alle accuse di escapismo rivolte alla letteratura fantastica in generale e alle opere di Tolkien in particolare. Infine, The Iron Dragon’s Daughter (1993), The Dragons of Babel (2008) e The Iron Dragon’s Mother (2019) costituiscono una trilogia di romanzi autoconclusivi che condividono la stessa ambientazione, mentre – come è noto – la divisione de Il Signore degli Anelli in tre libri è stata una scelta dettata dall’editore.
Peraltro non bisogna dimenticare che Swanwick attinge a una delle fonti da cui trasse ispirazione Tolkien, la mitologia celtica. Non solo troviamo citati luoghi leggendari come Avalon, Lyonesse, Ys, Tír na nÓg, Mag Mell, Broceliande, a volte spogliati del loro significato mitico, ma anche nomi gallesi (o grafie simil-gallesi) e riferimenti alla mitologia gallese, come per esempio Caer Gwydion (letteralmente la “fortezza di Gwydion”), ovvero il nome gallese della Via Lattea; i Tylwyth Teg, nome gallese per indicare il Popolo delle Fate; Gwenhidwy, nome della moglie di Gwydion e di una sirena del folklore gallese; o l’awen, l’ispirazione poetica dei bardi gallesi. Inoltre, secondo Tom Shippey, il massimo critico tolkieniano, Swanwick potrebbe essersi ispirato ai The Denham Tracts – una raccolta di folklore britannico risalente alla seconda metà dell’Ottocento –per la lista di creature magiche che compaiono nella sua opera[6]. Nel secondo volume di questa raccolta compare un lunghissimo elenco di termini associati al folklore dell’Inghilterra settentrionale, tra cui la prima occorrenza del termine hobbits[7].
Il mondo in cui vive Jane è Faërie, il Mondo delle Fate, ma è una realtà parallela e superiore alla nostra. Un mondo popolato di ogni sorta di abitante del Piccolo Popolo e del folklore europeo: elfi, demoni, folletti, coboldi, orchi, troll, gargoyle, nani, streghe, fate, ninfe, gnomi, goblin, ma anche varie figure di spiritelli meno noti, come lutin (dalle leggende francesi), hogboon (dal folklore delle Orcadi), powrie (dal folklore scozzese), lešij (dalla mitologia slava), gwarchell (dal folklore gallese, citato anche da Grimm nel suo Deutsche Mythologie), nisse (dal folklore scandinavo), pillywiggin (dal folklore britannico). Queste creature fatate, tuttavia, non hanno nulla a che spartire con le fays vittoriane e gli alti elfi descritti da Swanwick – uomini d’affari senza scrupoli che vestono completi firmati – sono ben altra cosa rispetto agli aristocratici elfi tolkieniani. Un mondo spietato, violento, corrotto, industrializzato e consumista, in cui troviamo centri commerciali, locali notturni, catene di fast food, nani comunisti che combattono in nome della lotta di classe ed elfi dell’alta società che aspirano strisce di “polvere di fata”, ma anche reginette della scuola coinvolte in sacrifici umani alla The Wicker Man, mani di gloria e magia sessuale. L’uso di termini o elementi familiari al lettore calati in un contesto fantastico crea una sensazione di spaesamento, di dissonanza cognitiva, e questa sovrapposizione tra i due mondi contribuisce ad aumentare lo straniamento. Talvolta ci si trova di fronte ad apparenti incongruenze, come il riferimento a un «completo italiano», una «scarpa italiana» o ancora alle «sciarpe italiane» finite non si sa come nel Mondo delle Fate o al vino cecubo decantato da Orazio. In altri casi, l’autore si vale di un procedimento inverso, quello di camuffare oggetti della nostra realtà sotto nomi che ci risultano disorientanti, alieni: per esempio, così come i draghi vengono usati come caccia militari, le auto sono dunque «cavalli di cromo» e i camion in «behemoth d’acciaio».
Come se non bastasse, ad arricchire questo chimerico calderone ribollente di spunti filosofici e contaminazioni letterarie non mancano citazioni neanche troppo velate al nostro mondo: Swanwick mette in bocca ai suoi personaggi le parole pronunciate da Neil Armstrong durante l’allunaggio, una celebre frase di Robert Oppenheimer tratta dalla Bhagavadgītā, riferimenti all’incipit di Neuromante (1984) di William Gibson, alla poesia Goblin Market (1862) di Christina Rossettie allo pseudobiblion Culti indicibili inventato da Robert E. Howard.
[1]J. Clute – J. Grant (ed. by), The Encyclopedia of Fantasy, St. Martin’s Press, New York 1997, p. 914
[2]<https://floggingbabel.blogspot.com/2019/06/my-accidental-trilogy_25.html>
[3]<https://paulsemel.com/exclusive-interview-the-iron-dragons-mother-author-michael-swanwick/>. Sul rapporto con Tolkien, cfr. anche M. Swanwick, “A Changeling Returns” in K. Haber (ed. by), Meditations on Middle-earth, St. Martin’s Press, New York 2001, pp. 33-46
[4]M. Swanwick, Hope-in-the-Mist: The Extraordinary Career and Mysterious Life of Hope Mirrlees, Temporary Culture, 2009
[5]<http://www.infinityplus.co.uk/nonfiction/intms.htm>
[6]Cfr. T. Shippey, “Fighting the Long Defeat: Philology in Tolkien’s Life and Fiction” in id. Roots and Branches, Walking Tree Publishers, Zurich and Berne 2007,p. 154 e “The Faërie World of Michael Swanswick” in D. Fimi – T. Honegger (ed. by), Sub-creating Arda: World-building in J.R.R. Tolkien’s Works, its Precursors, and Legacies, Walking Tree Publishers, Zurich and Berne 2019.
[7]J. Hardy (ed.), The Denham Tracts. A Collection of Folklore by Michael Aislabie Denham, and Reprinted from the Original Tracts and Pamphlets printed by Mr. Denham between 1846 and 1859, Vol. II, The Folklore Society, London 1895, p. 79