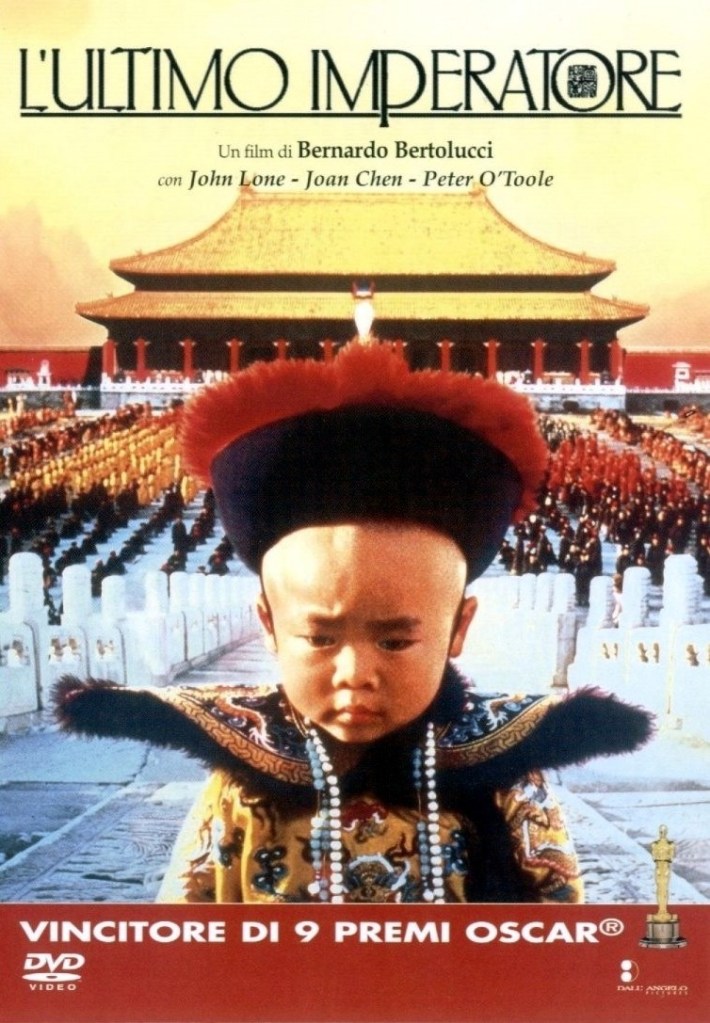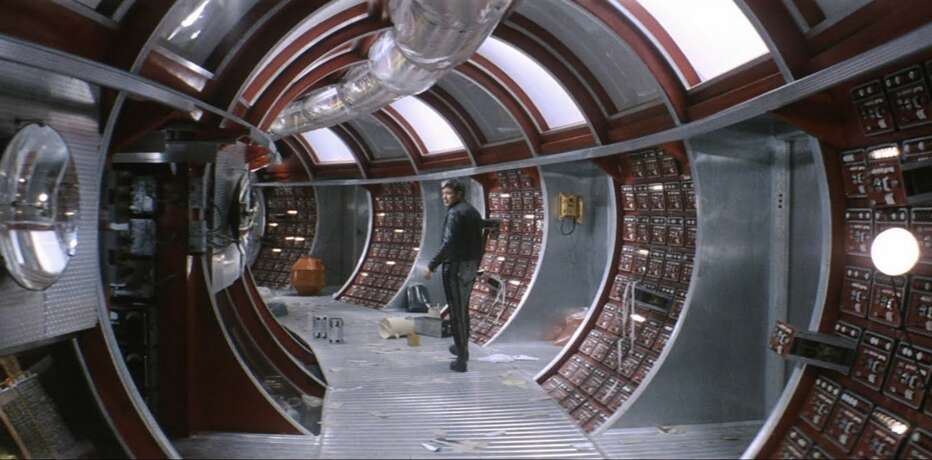Ho visto il film di Andrea Segre su Enrico Berlinguer. La mia curiosità è stata stimolata dalla grande propaganda che intorno ad esso è stata sapientemente orchestrata attraverso i mass-media. Confesso di essere rimasto deluso. Sia chiaro: il regista ha dimostrato tutta la sua competenza tecnica e l’attore protagonista ha dato ampio saggio della sua professionalità.
Ma, al di là dell’aspetto prettamente tecnico, si pone inevitabilmente la questione dei contenuti, del modo in cui sono stati presentati al pubblico gli avvenimenti oggetto della rappresentazione cinematografica. Ho trovato il film marcatamente agiografico. A mio avviso, la «strategia comunicativa» perseguita abilmente dal regista è stata quella di coniugare due esigenze fondamentali.
Da un lato, assecondare la nostalgia intorno alla figura di Berlinguer che anima una fascia di pubblico che ha condiviso, per motivi generazionali, la sua esperienza politica di segretario nazionale del Partito comunista italiano. Si tratta di un’ampia area di persone che, nei decenni a seguire, hanno perlopiù seguito un percorso comune, che è quello dell’adesione ai vari partiti (Pds, Ds, Pd) che sono nati per effetto dello scioglimento del Pci e che trovano conforto nella politica del «compromesso storico» portata avanti da Berlinguer per giustificare la scelta di un processo politico che si è concluso con la nascita di un soggetto, il Partito democratico, che ha unito in sé una parte degli ex comunisti e una componente dell’ex Democrazia cristiana.
Dall’altro lato, il regista ha voluto consolidare una certa immagine di Berlinguer e del Pci a beneficio delle nuove generazioni, presenti e future. Un progetto ambizioso, che sicuramente è destinato ad incidere e ad ottenere risultati tangibili.
Un film agiografico, dicevamo, e, per ciò stesso, poco problematico, conseguentemente esaltatorio e tutto volto ad agire sulla sfera emotiva del pubblico, piuttosto che sulla riflessione critica e, per quanto riguarda i più anziani, anche autocritica.
E’ vero: la personalità di Berlinguer viene ricostruita come tormentata, angosciata dal susseguirsi di avvenimenti drammatici, che hanno un epilogo disastroso, seppur improntata ad alcune scelte di fondo che il politico intende perseguire in maniera intransigente. La «grande ambizione», di cui parla il titolo del film, è quella di dar vita, attraverso il «compromesso storico», ad una collaborazione tra le maggiori forze politiche di estrazione popolare, la Dc e il Pci, per realizzare nel Paese un sistema di riforme tale da assicurare un cambiamento in senso democratico e progressista.
La ricostruzione storica degli avvenimenti è, però, tendenziosa, tutta incentrata sulle passioni del protagonista, sulle sue idee, perseguite con coerenza, sul suo spessore umano e politico-culturale. La prima vittima sacrificale è rappresentata dal dibattito interno al Pci suscitato dal «compromesso storico». Un dibattito che fu aspro, vide posizioni fortemente contrapposte, anche se, in buona parte, fu soffocato dal segretario e dal gruppo dirigente raccolto intorno a lui con la defenestrazione dei suoi antagonisti o con la loro emarginazione attraverso metodi molto discutibili e tutt’altro che democratici.
Nel film questi antagonisti vengono ridotti al rango di semplici comparse, alle quali viene affidata la pronuncia di qualche frase. E’ questa una rappresentazione molto riduttiva di personaggi come Umberto Terracini, fondatore del partito nel 1921, assieme a Gramsci e a Togliatti, condannato dal regime fascista a 22 anni di reclusione, presidente, nell’immediato secondo dopoguerra, dell’Assemblea Costituente, a cui fu affidato il compito di redigere la nuova Costituzione, che porta in calce la sua firma, capogruppo del partito al Senato per lunghi anni e figura di primo piano della lotta politica; come Pietro Ingrao, al quale viene affidata nel film una frase isolata, seppur significativa (laddove egli contesta il progetto di realizzare il cambiamento della società italiana collaborando con la Dc e con uomini come Andreotti che hanno malgovernato per decenni il Paese e sulle cui spalle si addensano pesanti responsabilità); come Luigi Longo, segretario del partito prima di Berlinguer e poi presidente, che manifestò tutta la sua contrarietà al «compromesso storico», a partire dalla stessa definizione adottata, ma che nel film non fa neanche capolino.
Armando Cossutta compare di sfuggita nel momento in cui viene destituito da Berlinguer dal suo compito di tenere i rapporti con il Pcus, sostituito da Gianni Cervetti, e affidato al settore degli Enti locali, e pronuncia brevi frasi che racchiudono la sua preoccupazione per una rottura con l’Unione Sovietica nel momento in cui il Pci è esposto a gravi pericoli che provengono da tutt’altra direzione, come lo sviluppo degli avvenimenti dimostrerà ampiamente. L’immagine di Cossutta come semplice uomo di Mosca è anch’essa molto riduttiva. Si tratta di un dirigente che viene dalla Resistenza ed è stato chiamato a far parte della segreteria nazionale dal segretario che ha preceduto Berlinguer, Luigi Longo, per l’appunto. In linea con le posizioni di quest’ultimo, è stato pubblicamente contrario all’intervento delle truppe del Patto di Varsavia in Cecoslovacchia, e, successivamente, sotto la segreteria Berlinguer, all’intervento sovietico in Afghanistan, nel 1979. E’ la persona a cui Longo ha affidato il compito di occuparsi dei rapporti con l’Urss per conto del Pci, del quale ha rappresentato gli interessi nelle relazioni bilaterali.
Nel film non compare Ambrogio Donini, storico delle religioni, docente universitario, uno dei capi del Centro esteri del Pci durante il fascismo, esule in vari Paesi nel ventennio della dittatura mussoliniana, autore di un tentativo di liberare Gramsci dalla prigionia attraverso una trattativa mediata dal Vaticano, primo lettore dei Quaderni del carcere, assieme a Togliatti, pervenuti avventurosamente in copia. Donini è il vero punto di riferimento del Pcus in Italia. Sarebbe un’offesa alla sua cultura accademica considerarlo un grigio e dogmatico uomo d’apparato. E’ uno di quelli con i quali Berlinguer ha usato la mano pesante, escludendolo nel 1979 dalla Commissione Centrale di Controllo senza neanche preavvisarlo, come emerge dalla corrispondenza epistolare intrattenuta da Donini con Nino Pino Balotta, già deputato comunista nelle prime tre legislature della Repubblica e anch’egli amico dell’Urss, come uomo di cultura e scienziato di fama internazionale.
L’elenco di coloro che sono stati estromessi ad opera di Berlinguer e dagli uomini che lo attorniano è abbastanza lungo. Si tratta di dirigenti di vecchia data che hanno servito la causa in circostanze difficili, pagando di persona. Un patrimonio di esperienze di cui Berlinguer ha ritenuto di dover privare il partito, mettendo al loro posto persone che poi l’hanno sciolto, come Achille Occhetto, Massimo D’Alema, Walter Veltroni, Piero Fassino (solo per fare alcuni nomi).
Il film rappresenta il dramma personale di Berlinguer di fronte al rapimento del segretario della Dc, Aldo Moro, e al fallimento del «compromesso storico». Ma non dà conto di quello di migliaia di militanti e di ex dirigenti, defenestrati ai vari livelli, che hanno subito enormi discriminazioni nell’ambito del nuovo sistema creato da Berlinguer assieme alla Dc e al quale è stato dato il nome di «consociativismo».
Non mostra gli effetti nefasti della politica della «concertazione» nei confronti della massa dei lavoratori. Qui basta ricordare che, lungo la scia del «compromesso storico», Luciano Lama, segretario della Cgil, con la «svolta» dell’Eur, nel 1978, accettò la politica di riduzione dei salari, in nome della partecipazione dei lavoratori ai sacrifici imposti dalla crisi economica, in cambio di un promesso aumento dell’occupazione che non si ebbe.
Non rappresenta l’effetto politico principale del «compromesso storico» nell’ambito della sinistra italiana: l’indebolimento del Psi (di fronte ad un accordo tra i due maggiori partiti non poteva che risultare soccombente), la conseguente emarginazione interna del segretario pro tempore Francesco De Martino, l’ascesa al potere di Craxi, in nome dell’autonomismo socialista, che portò da lì a poco alla sua investitura a segretario del partito. I rapporti tra comunisti e socialisti ne risultarono compromessi per sempre e le prospettive di un’alternativa della sinistra alla Dc svanì.
Il film di Andrea Segre ritiene opportuno concludere con il rapimento Moro, tralasciando tutti gli aspetti che ho segnalato e la loro proiezione distruttiva sulla vicenda politica futura.
E’ un film che fa leva sull’emozione acritica e sulla nostalgia, presunta e ingiustificata, piuttosto che sulla ragione critica e sulla riflessione storica, molto più complessa ed articolata.