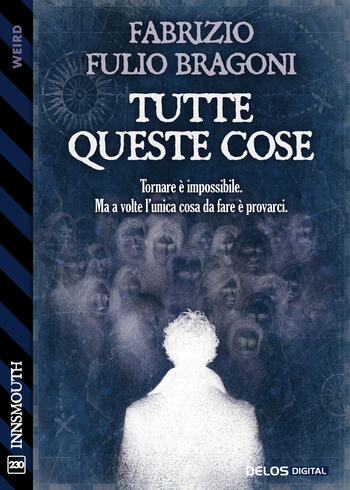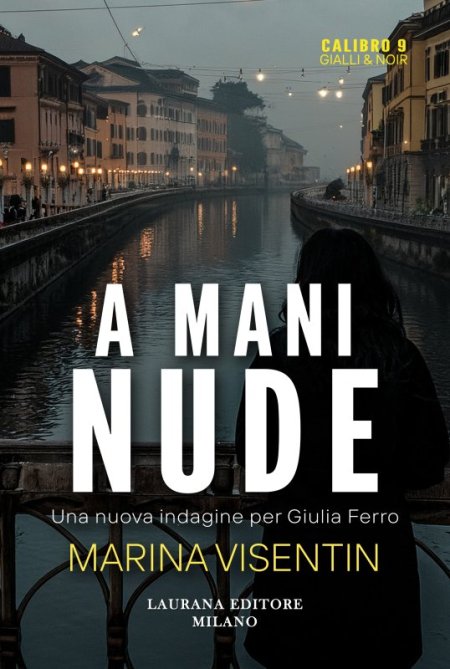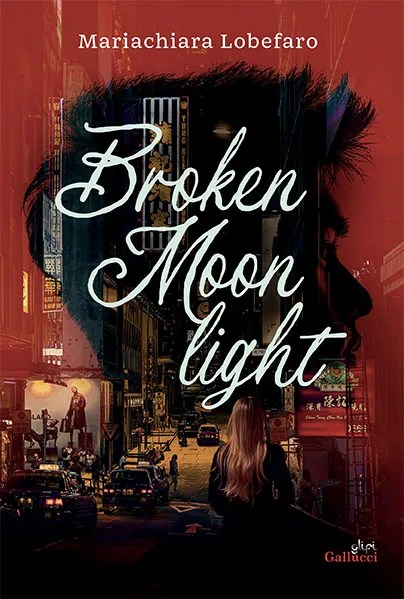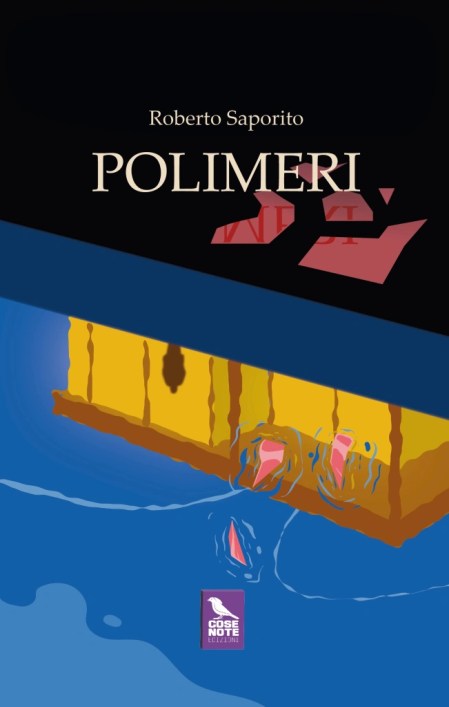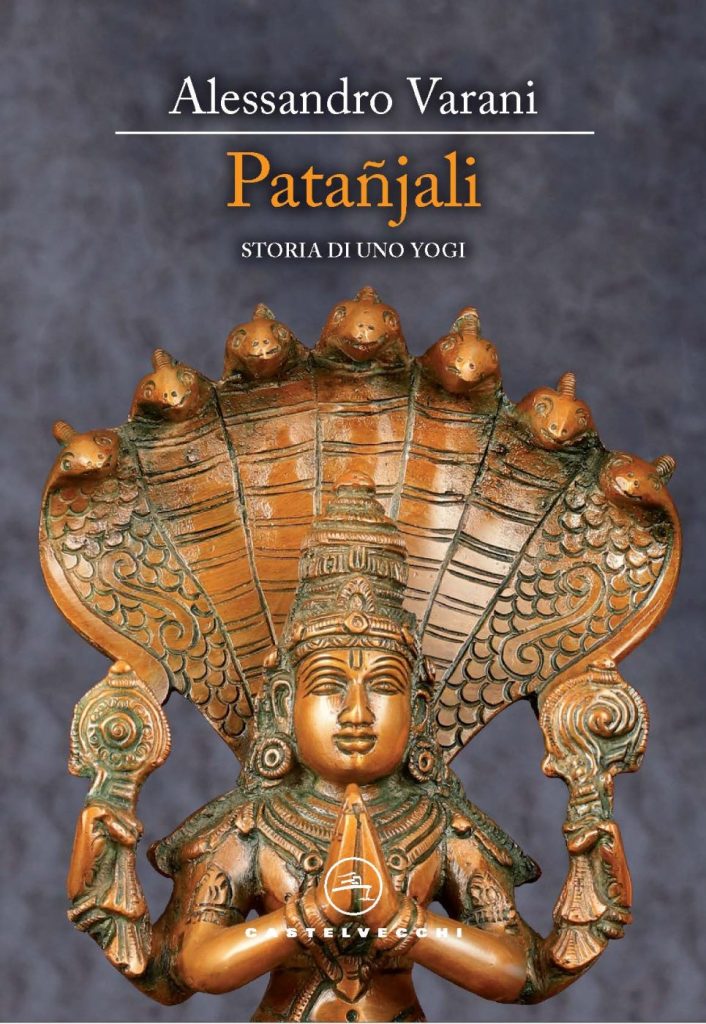
Alessandro Varani ha pubblicato per Castelvecchi il libro dedicato alla vita di colui che è rienuto il “fondatore” dello Yoga: Patañjali. “Patañjali. Storia di uno Yogi” narra l’esistenza di colui che visse tra il III e il II secolo a.C., quando l’impero indiano, dopo avere ottenuto il massimo della sua espansione territoriale e culturale, cominciò un lenta decadenza. In questo mondo Patañjali portò a compimento un cammino di formazione umana e spirituale passato alla storia come un testamento filosofico e spirituale: gli Yogasutra. Del romanzo ne abbiamo parlto con il suo autore.
Alessandro ben trovato. Da occidentale, come ha scoperto la figura di Patañjali?
Molti anni fa, praticando e studiando Yoga ho scoperto gli Yoga-sūtra di Patañjali. Da subito, rimasiaffascinato da questi ‘aforismi’, pregni di saggezza e consigli pratici su come progredire nel campo della ricerca interiore. Intuivo che l’apparente incomprensibilità di alcuni sūtra dipendeva dal fatto che non si trattava tanto di leggerli per capirli, quanto di esperirli uno ad uno, attraverso una pratica guidata da un maestro che comportava una trasformazione personale nello stile di vita, ma soprattutto mentale e interiore.
Perché ha deciso di scrivere il libro sullo yogi?
Nel 2018, dopo tanti anni di pratica e insegnamento dello Yoga, ho sentito l’esigenza di scrivere un testo che facesse giustizia delle mistificazioni che questa antica e universale disciplina di conoscenza del sé ha subito in Occidente da quando venne importata, ormai più di un secolo fa. Cominciò in questo modo a prendere forma nella mia mente l’idea di fornire al lettore un modello esemplare per descrivere un sano, autentico percorso yogico. La scelta dello yogin protagonista del romanzo cadde allora su Patañjali, una figura leggendaria in India, ma praticamente sconosciuta anche a molti fra i praticanti di Yoga occidentali. Inoltre, le scarse e a volte confuse fonti su Patañjali (vissuto circa nel II° sec a.C.) mi consentivano di sviluppare una trama narrativa in piena libertà, pur mantenendo il rigore storico dell’ambientazione e l’autenticità del contenuti filosofici e spirituali presenti nel romanzo.
Come si è mosso per la stesura del libro per quanto riguarda ricerca e recupero di informazioni e
materiale?
Premetto che la stesura del libro, durata più di cinque anni, è stata una sfida davvero impegnativa che mi ha fornito stimoli anche come insegnante di Yoga. Certamente lo studio delle fonti storiche, letterarie e religiose mi è stato utile per entrare nell’atmosfera socio-culturale dell’India antica, ma ho dovuto integrare quelle fonti necessariamente con una vera e propria intuizione sulla figura di Patañjali, di cui biograficamente non si sa quasi nulla. Ho adottato un procedimento ‘a ritroso’, cercando di ricostruire la personalità di Patañjali a partire dallo studio meditativo su tre testi a lui riferiti: gli Yoga-sūtra, un grande commentario di grammatica sanscrita (Mahabhashya) e un commentario di medicina ayurvedica (Carakavārttika). Aggiungo che per la stesura del testo ho seguito la tradizione indiana che unifica le tre persone in un solo autore, piuttosto che quella degli studiosi che perlopiù oggi tendono a separare la figura del Patañjali scrittore degli Yoga-sūtra da quella dal grammatico.
Come è stato mescolare realtà e finzione?
Certamente entusiasmante e spaventoso al contempo. La sfida di cui prima parlavo è consistita soprattutto nel mantenere insieme vero e verosimile, armonizzando fra di loro i diversi livelli di lettura del testo. Questo mi ha richiesto una rigorosa, costante attenzione, perché sapevo che per quanto quei livelli avrebbero costituito l’originalità del testo, lo sviluppo della trama e delle vicende umane narrate nel romanzo dovevano restare al centro dell’interesse del lettore, integrandosi al meglio alla cornice storica, filosofica e spirituale del testo. Spero di esserci riuscito.
Il percorso vissuto da Patañjali, gli incontri e le esperienze che fa possono essere viste anche come un
percorso di formazione? Assolutamente sì, essendo una biografia romanzata in senso lato, in cui seguiamo la vita del personaggio: la sua nascita, la formazione nella scuola yogica del padre brahmano, un primo matrimonio, fino alla crisi
spirituale che lo porterà alla rottura con la propria famiglia, mettendolo sul cammino di una tortuosa ricerca spirituale, fra buddhismo e pura ascesi, e quindi l’esperienza dell’auto-realizzazione, seguita dal ritorno in società, con le crisi e i dolori familiari, infine alla corte dell’imperatore Indiano Pushyamitra, sullo sfondo di persecuzioni religiose e della guerra contro i Greco-battriani… In definitiva, si tratta della narrazione di una inesausta ricerca di saggezza e libertà lungo tutto l’arco esistenziale del personaggio Patañjali.
La cosa interessante del libro è che oltre alla vita ci sono anche nozioni sulla pratica delle yoga?
Questo era un’altro obiettivo che mi ero riproposto, ovvero di narrare in parallelo alla vita dell’uomo quella dello yogin. In effetti, il sottotitolo del romanzo, ‘vita di uno yogin’ sta lì a indicare che il libro tratta dell’uomo Patañjali, come pure della vita di chi pratica lo Yoga e che proprio applicando gradualmente le diverse tecniche che i maestri gli propongono progredisce sul piano umano e spirituale. In virtù della mia lunga esperienza come insegnante di Yoga, ho potuto descrivere accuratamente alcune pratiche autentiche. Soprattutto, facendo capire al lettore l’importanza del respiro nello Yoga, perché la respirazione costituisce davvero il cuore pulsante di questa disciplina. Il respiro permette al praticante di Yoga di prendere coscienza della propria energia vitale (prāna) avvalendosi delle tecniche yogiche che insegnano a non disperderla, anzi a concentrarla tramite la mente su obiettivi conoscitivi interiori tramite il processo meditativo.
Cosa l’ha spinta a mettere assieme queste due componenti?
Per certo, la volontà di rendere giustizia a questa mirabile e nobile disciplina, spesso fraintesa. E mi spiego meglio: lo Yoga classico, come lo intende Patañjali, è una disciplina che si occupa principalmente del mentale, secondo la definizione che troviamo scritta nello Yoga-sūtra II.2, dove egli afferma che lo ‘Yoga è l’arresto della attività mentali” e dove tutti gli esercizi fisici, oggi molto in voga, svolgono solamente una funzione preparatoria e di minore importanza rispetto alle tecniche respiratorie e di concentrazione. Dall’altra parte, essendo lo Yoga arrivato in Occidente tramite dei grandi maestri che erano dei monaci, quali Vivekananda e Yogananda, si è presto associata questa autonoma disciplina di ricerca spirituale che prescinde da ogni religione, con l’induismo. In Occidente, questa confusione iniziale spesso ha prodotto atteggiamenti esotico-misticheggianti, esaltati negli anni settanta del secolo passato dalla moda fricchettona degli hippies che andavano in India a riscoprire la spiritualità…
Come è cambiato o cosa è cambiato nella sua vita quotidiana e lavorativa da quando pratica lo yoga?
Direi tanto, se non tutto. Nel senso che lo Yoga, quando funziona, prevede una trasformazione dello stile di vita e della personalità del praticante, parallela a una presa di coscienza di se stessi sempre più approfondita. Pratica dopo pratica, purificazione dopo purificazione, lo Yoga ci rende infine degni di ricevere l’epifania spirituale dell’auto-realizzazione, un’esperienza che stravolge radicalmente il nostro precedente punto di vista sulle cose del mondo, donandoci grande fiducia e contentezza interiore.
Ci fa un breve cenno alla sua associazione culturale Yoga Sāram Studio?
Ho fondato questa associazione culturale con il precipuo scopo di diffondere lo Yoga sui principi che ho esposto rispondendo alle precedenti domande. Posso aggiungere che è dall’inizio del mio percorso di conoscenza interiore che cerco di mantenere vivo uno scambio sapienziale tra Oriente a Occidente. D’altra parte, i mistici di ogni tempo e angolo del pianeta, attraverso le loro esperienze interiori, hanno da sempre ribadito che l’essenza spirituale degli esseri umani è la medesima. Infatti, le testimonianze relative a esperienze di luce divina dei contemplativi, siano questi Occidentali o Orientali, laici o religiosi, sono e saranno sempre le stesse in ogni parte del mondo, perché questo è il Bello, il Buono e il Giusto che anima le diverse culture, anche nelle loro distinte peculiarità: il tutto è Uno.