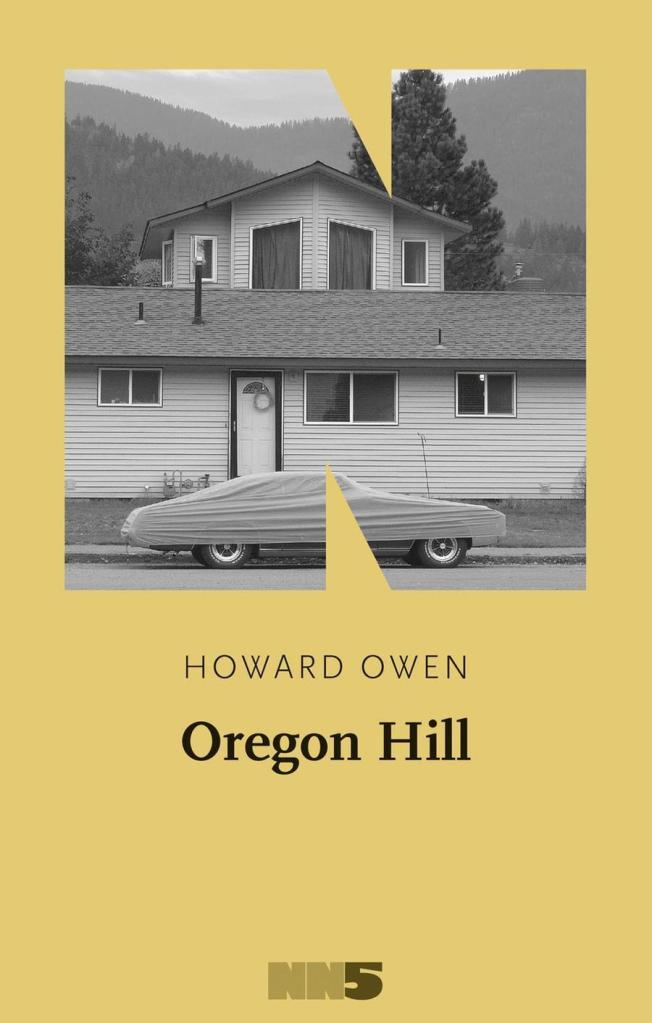
Grazie a NN Editore, ormai punto di riferimento imprescindibile per chi ama la letteratura americana, arriva nelle librerie italiane Howard Owen, autore di una ventina di romanzi molti dei quali dedicati al giornalista Willie Black. E proprio Willie Black è il protagonista di questo Oregon Hill, noir dal forte impianto civile, attraversato da toni blueseggianti e malinconici. Ma partiamo dal titolo: Oregon Hill è il quartiere operaio della città di Richmond nello stato della Virginia in cui Black ha passato l’infanzia. È il posto in cui ancora abitano molti suoi amici, nonché una madre più bisognosa di venire accudita di quanto sia qualsiasi figlio. Non è un particolare secondario in un libro che fa della sua geografia un elemento narrativo di primo piano. L’indagine di Black attraversa infatti la città mappandone confini e anfratti, zone residenziali e bassifondi. Owen è attentissimo al genio del luogo, così come è preciso e minuzioso nel descrivere le differenze di classe dei suoi protagonisti. Anzi, in una realtà come la nostra, che ha progressivamente (e inesorabilmente) visto erodere il mondo del lavoro e i suoi diritti, lo sguardo di Owen acquista un rilievo sociologico raro nel poliziesco. In fondo la storia di Oregon Hill è anche una storia di odio di classe, declinata senza retorica e luoghi comuni. Uno degli aspetti più convincenti dell’arte di Owen è proprio quello di mettere in scena personaggi prismatici, dei quali è facile riconoscere i torti ma anche le ragioni. In questo senso Willie Black incarna un eroe noir archetipico. Abbastanza smagato da affrontare il male del mondo con sarcasmo e una buona dose di umanità, Black non si fa illusioni sugli esseri umani, ma non per questo sottovaluta il potenziale di bontà che chiunque può manifestare. Ma di cosa parla precisamente Oregon Hill? Di un delitto, naturalmente. Una studentessa viene trovata decapitata. Un poliziotto ansioso di chiudere il caso offre al pubblico e al sistema dei media il colpevole perfetto: un uomo frequentato dalla ragazza, un poco di buono manesco e con una certa inclinazione per le droghe. Ma le cose non sono così semplici e le apparenze, nel mondo a doppio fondo del thriller, facilmente ingannano. Lontanissimo da atteggiamenti stereotipati, Black conduce la sua inchiesta muovendosi tra sottotrame familiari che danno la misura della brillante capacità descrittiva di Owen. Bellissimo il modo in cui viene reso l’ambiente del giornalismo di piccolo cabotaggio del quale il nostro protagonista fa parte. La vita di redazione, con i suoi opportunismi e le sue reticenze, la precarietà che compromette anche i legami più saldi. Black è un uomo decisamente maturo, ha quasi cinquant’anni, diversi matrimoni alle spalle e una figlia con cui i rapporti non sono facili. Oltre a questo deve fatalmente fare le spese della grande crisi che ha sconvolto l’America e il mondo e soprattutto deve vedersela con la rivoluzione tecnologica (e antropologica) che ha trasformato il giornalismo per come lo conosceva. In fondo una delle grandi dialettiche del noir da Chandler in poi è quella che contrappone l’(anti)-eroe al proprio tempo. Da questo punto di vista Willie Black non fa eccezione: uomo e giornalista novecentesco che è costretto a fare i conti con l’informazione online, i blog, modalità del tutto nuove di fabbricare e guidare il consenso. Romanzo trascinante e ricco, abilissimo nel descrivere le mille complessità di una società imprendibile, Oregon Hill sembra dare ragione al maestro francese Jean Patrick Manchette quando individuava nel poliziesco il vero genere beahviourista nonché la più autentica letteratura di intervento sociale.
Howard Owen è nato in North Carolina, ma vive a Richmond, Virginia. Ha lavorato come giornalista per quarant’anni e ha scritto numerosi romanzi di genere. Con Oregon Hill, il primo libro della serie di Willie Black, ha vinto l’Hammett Prize, dopo scrittori come Elmore Leonard, Margaret Atwood, George Pelecanos e Stephen King.
Source: libro inviato dall’editore al recensore, ringraziamo Francesca Rodella dell’Ufficio stampa NN editore.
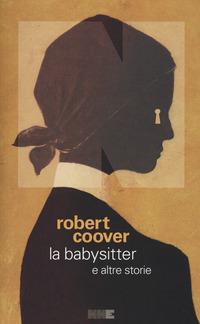 Da colpevole semplificatore quale sono ho sempre pensato che la letteratura americana potesse essere facilmente (e banalmente) scissa in due macroaree. Da un lato autori passionali, viscerali, caldi, dall’altra scrittori mentali, azzimati, freddi. Da un lato una tradizione che potremmo far risalire a Hawthorne e alle sue indagini sulle origini di un paese che lui stesso vedeva assemblarsi, dall’altro una genia più complessa da definire e che può trovare padri spirituali in figure più asimmetriche come Washington Irving. In mezzo potremmo tranquillamente inserire la pietra angolare Hermann Melville, viscerale quant’altri mai ma anche capace di azzardi stilistici mai più ripetuti (salvo poi, in Mobydick, di fatto inventare il flusso di coscienza). Sono distinzioni pedestri e con le quali rivelo la mia fragilità di analisi di fronte a un gigante come Robert Coover da noi pochissimo tradotto (a memoria mia ricordo solo il bellissimo romanzo breve Sculacciando la cameriera) che, organico a un’idea di letteratura in cui possiamo incontrare John Barth e Kurt Vonnegut, William Gass e Donald Barthelme, brandisce la bandiera del post moderno ma da una prospettiva personalissima. Difficile, partendo da questa scelta antologica che abbraccia una produzione che, dal 1962 del primo racconto, arriva al 2016 de L’invasione dei marziani, immaginare uno scrittore meno propenso a farsi incasellare in un genere o anche semplicemente in un atteggiamento, in una propensione, in quel che volete. L’arte di Coover è doppia, tripla, prismatica. A dimostrarlo c’è il racconto che dà il titolo alla raccolta e cioè La babysitter dove l’alternarsi impazzito dei punti di vista detta il ritmo e determina la storia.
Da colpevole semplificatore quale sono ho sempre pensato che la letteratura americana potesse essere facilmente (e banalmente) scissa in due macroaree. Da un lato autori passionali, viscerali, caldi, dall’altra scrittori mentali, azzimati, freddi. Da un lato una tradizione che potremmo far risalire a Hawthorne e alle sue indagini sulle origini di un paese che lui stesso vedeva assemblarsi, dall’altro una genia più complessa da definire e che può trovare padri spirituali in figure più asimmetriche come Washington Irving. In mezzo potremmo tranquillamente inserire la pietra angolare Hermann Melville, viscerale quant’altri mai ma anche capace di azzardi stilistici mai più ripetuti (salvo poi, in Mobydick, di fatto inventare il flusso di coscienza). Sono distinzioni pedestri e con le quali rivelo la mia fragilità di analisi di fronte a un gigante come Robert Coover da noi pochissimo tradotto (a memoria mia ricordo solo il bellissimo romanzo breve Sculacciando la cameriera) che, organico a un’idea di letteratura in cui possiamo incontrare John Barth e Kurt Vonnegut, William Gass e Donald Barthelme, brandisce la bandiera del post moderno ma da una prospettiva personalissima. Difficile, partendo da questa scelta antologica che abbraccia una produzione che, dal 1962 del primo racconto, arriva al 2016 de L’invasione dei marziani, immaginare uno scrittore meno propenso a farsi incasellare in un genere o anche semplicemente in un atteggiamento, in una propensione, in quel che volete. L’arte di Coover è doppia, tripla, prismatica. A dimostrarlo c’è il racconto che dà il titolo alla raccolta e cioè La babysitter dove l’alternarsi impazzito dei punti di vista detta il ritmo e determina la storia.























