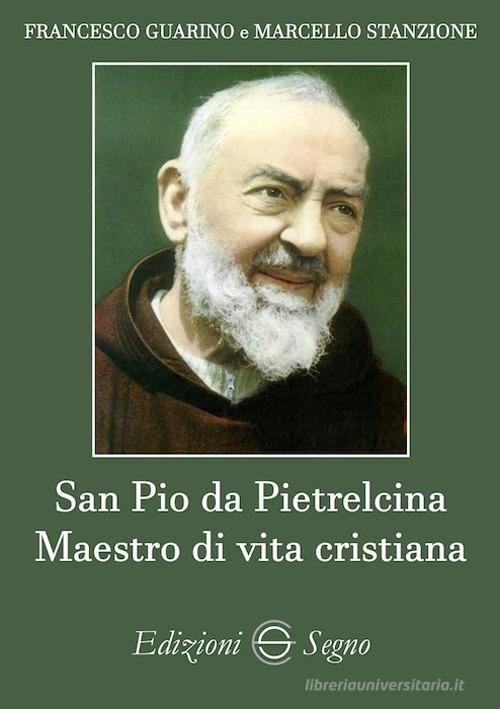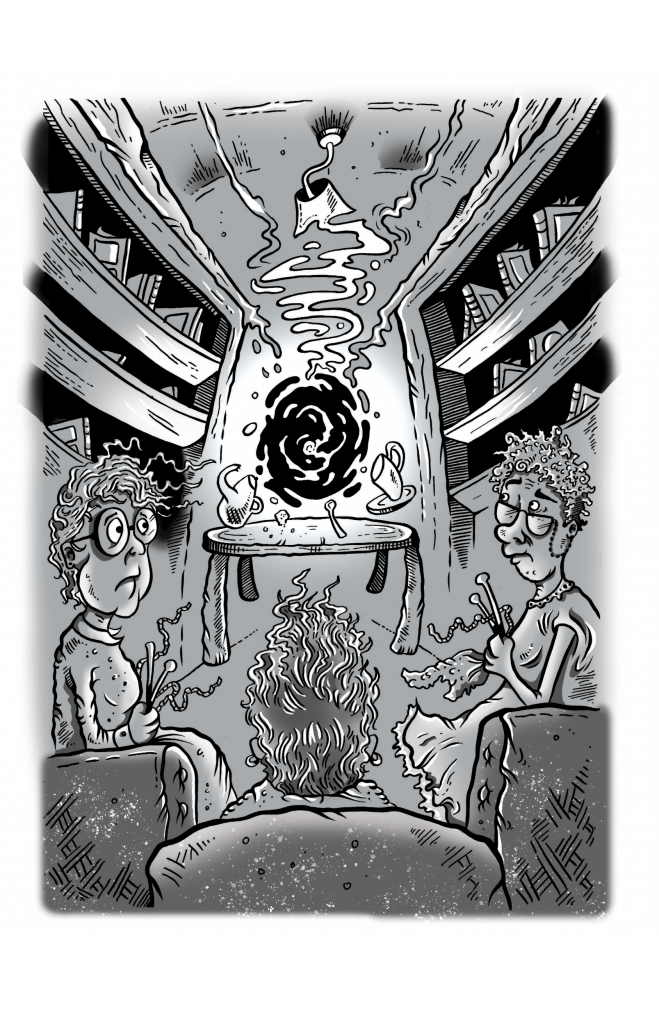No, non è come pensi. Non sto parlando di quella volta che A., in arte Sperminator, ha ben deciso di lasciare incinta una super cougar (ormai agli sgoccioli del suo periodo fertile), mentre stava con me. Da 7 anni, ma questo è un dettaglio.
E nemmeno di quando M., al momento di inaugurare con il botto la nostra carriera da professionisti, ha ben pensato di sostituirmi con un’altra partner. Me la sono trovata praticamente sulla mia soglia con le sue valigie, pronta a trasferirsi, mentre io, ignara, stavo preparando le mie per le agognate vacanze.
Vabbè, in entrambi i casi, sarebbe comunque finita, giusto? Io ero giovane e inesperta. Loro erano giovani e inesperti. Tranne la cougar, quella sì che aveva grande esperienza.
Non parlo di quel genere di tradimento. No. La mia emotional coach mi ha ordinato di riflettere su ciò che per me significa questa parola, dopo essermi recata da lei, sconvolta e schizzata, in seguito ad un potente burnout. Troppo lavoro, troppi impegni, troppa gente (e relativi problemi) con cui avere a che fare e…bam, KO.
“Che c’entra il tradimento?”, ti chiederai, e a ragione, visto che gli episodi di cui sopra sono accaduti, come ti dicevo, quando ero ancora giovincella, mentre adesso, foto profilo a testimonianza, sotto le meravigliose (e costosissime) meches biondo cenere, c’è più cenere che biondo.
Mi sa che devo chiarire un po’ di cose. Lo faccio più per me che per te, sappilo!
L., la mia emotional coach che, per inciso, è pure una competentissima naturopata, nonché amica, sostiene che il mio cane Y. manifesti comportamenti aggressivi, perché fin da piccolo si è sentito tradito.
“E che c’entra il tuo cane, ora?”, potresti (giustamente) chiederti.
C’entra c’entra, te l’assicuro.
Dunque, Y. è un cane che è giunto a me e al mio attuale compagno, dopo un sequestro di un furgone proveniente dall’Est, che conteneva una trentina di cuccioli destinati ad essere venduti al Sud con traffici illeciti. Tra la ventina di sopravvissuti c’era lui, piccolo bouledogue francese, magrolino, tutto occhioni e orecchie paraboliche e…figlio di Satana.
Da subito ci siamo accorti che gli piaceva mordicchiare. Me, in particolare. E crescendo, lo faceva con sempre maggior convinzione e con sguardo diabolico. Ho provato a dichiarare la mia preoccupazione a compagno, amici ed educatori cinofili vari, ma tutti minimizzavano ed io non riuscivo a provarlo, perché il demone stava sempre ben attento a non farsi sgamare.
Morale della favola: oggi, dopo 4 anni, la belva di 18 kg si è impossessata del divano e mi guarda beffarda quando, girando alla larga, mi dirigo verso la camera da letto, unico luogo in cui mi sento al sicuro e riesco a ricavarmi uno spazio per me e la mia privacy.
Non fraintendermi, lo amo. Tantissimo. Abbiamo i nostri momenti di assoluto affetto con coccole, bacini, carezzine e giochi. Però sono come una roulette russa: non sai mai quando arriva il momento di beccarti la pallottola. Nel dubbio, li faccio durare pochissimo. Poco e spesso, come i pasti ideali suggeriti dai nutrizionisti quotati (e anche da L.).
Insomma, tra una tenera leccata ed un morso imprevedibile, non contemplando le maniere forti come soluzione, ho optato per quelle che io stessa uso su di me quando c’è qualcosa che non va: L., per l’appunto.
Dopo vari tentativi, visto che il signorino non è così facilmente manipolabile (sia in senso fisico che mentale), siamo giunti a somministrargli i fiori di Bach, che con lui sembrano particolarmente efficaci. La situazione, da 2 anni a questa parte, è decisamente migliorata, anche se persistono ancora i momenti di aggressività in concomitanza con la pappa (sua e nostra) e con la nanna (guai a disturbarlo!).
Il lavoro su Y. è giunto ora ad una fase cruciale. E qui arriva lo spiegone sul tradimento. Senza svelarti i dettagliati retroscena e trucchi del mestiere di L., è emerso che in Y. perdura una memoria legata al momento in cui è stato separato dalla sua mamma, che di punto in bianco non l’ha più nutrito e, successivamente, le altre figure femminili subentrate sembrerebbe si siano rivelate particolarmente violente al momento di porgergli la ciotola. Questo spiegherebbe la sua avversione per il genere femminile, verso cui si fa tenero tenero in un primo approccio, ma poi, contestualmente ai pasti, subentra l’istinto e quel meccanismo atavico dell’“attacca o scappa”, che si attiva per paura (dice L.), presumibilmente di essere nuovamente tradito da chi dovrebbe, invece, nutrirlo. Una volta avrei detto: “valli a capire i cani”. Ma sai che oggi, quasi quasi, comincio a comprenderli…
Proprio per risolvere la paura di Y. del tradimento, L. ritiene che non sia casuale che questa parola abbia un significato pure per me. Conoscendo la mia storia (anzi, le mie storie), mi ha proposto di lavorare sulla stessa tematica contemporaneamente al mio cagnolino bipolare. Per puro spirito di sacrificio e di immolazione sull’altare dei martiri masochisti, ho acconsentito. Ed eccomi qui. Titubante. E già pentita. “Avresti potuto sottrarti con una scusa”, mi dirai. E ti pare che non l’ho fatto? Ti ricordi quando ti ho parlato del burnout? Quella era la scusa perfetta. Plausibilissima, tra l’altro, anche perché vera, reale. Insomma, dopo mesi in cui ho alternato, nell’ordine, febbri strane, mal di schiena paralizzante, afonia, ascesso all’incisivo inferiore e conseguente mascella stile Jigsaw, emorragia oculare, insonnia e aritmia notturna, sudorazione adolescenziale e sintomi violenti da premenopausa (non ti dico l’umore!) ho cominciato ad avere un leggero sospetto che qualcosa non andasse. Quando, dopo aver rallentato i ritmi di lavoro e cancellato qualche appuntamento, solo l’idea di aprire l’agenda per programmare il futuro (anche prossimo) o di ricevere una telefonata di un cliente mi faceva saltare come un giullare fuori dalla sua scatola, provocandomi tachicardia, ho realizzato che ero davvero satura. Figurati se, in condizioni del genere, potevo pure dedicarmi a rimestare il mio passato di tradimenti. Giammai. Semmai, avevo bisogno di un rimedio ad hoc per rimettermi in sesto. Con questo piglio, sconvolta e schizzata, come ti dicevo all’inizio, mi sono rivolta a L. che, puntualmente, mi ha riproposto la stessa soluzione. Niente lascia, solo raddoppia. Nel senso che, non solo mi tocca riflettere su questa cosa del tradimento, ma pure mi ha consigliato un preparato specifico che agisce proprio su questa informazione. Tutte le fortune!
Come vedi, ci sto girando intorno, ritardando il momento in cui giungere al punto.
Perché un punto non c’è. O meglio, non riesco a mettercelo. Solo virgole e tanti accapo. Forse ci starebbero bene dei punti e virgola, così da creare un elenco di elementi e situazioni che hanno una loro autonomia, ma che sono comunque legati (anche se talvolta non sembra).
Alla domanda: “Quali sono (o sono state) le situazioni in cui hai avuto a che fare con il tradimento?”, queste sono state le prime risposte che mi sono venute in mente:
- A. e la cougar;
- M. e la sostituta;
- S. e la tipa con cui si è imboscato (facendosi beccare dalla sottoscritta) dietro il bancone del bar in cui stavamo festeggiando il mio compleanno;
- Ex marito colto in flagrante dai miei mentre baciava una cara collega (e non sulla guancia);
Qui avrei potuto mettere quel famoso punto e invece…ancora punti e virgola. Perché non è solo questione di corna, a ben pensarci. E come una diga che non regge più e non vede l’ora di straripare, ecco che il mio subconscio comincia a vomitare innumerevoli altre occasioni in cui pure le amicizie non è che siano state poi così clementi. Per non parlare di colleghi, collaboratori e parenti.
Ma non basta. La cosa peggiore è che, a suon di riempire pagine e pagine con i nomi dei traditori, mi sono ritrovata a metterci l’unico nome che non avrei mai immaginato né voluto vedere scritto nero su bianco: il mio. Lettere cubitali e luminescenti come l’insegna al neon del peggior night club degli anni 90. Accidenti! (per non rischiare di essere scurrile, son pur sempre una signora…accidenti anche a questa parola, signora…argh!).
Davvero sono stata io la peggior traditrice? Ma di chi? Di me stessa, è ovvio. Io, che proprio perché ho subito in tenera età una grossa mazzata, mi ero ripromessa (croce sul cuore) di non tradire mai nessuno, perché il dolore inferto è atroce e chi mai si merita una pena così?
Mi chiederai: “Come l’hai scoperto? E in che modo hai tradito te stessa?”
Una risposta alla volta, porta pazienza.
L’ho scoperto grazie alla parabola del Demone Fankülizzatore, inventata da R., mio fratello d’anima, colui che mi appoggia, mi sostiene e mi vuole bene come nessun altro, uno dei pochi a non apparire nella lista. Insomma, secondo questa parabola, quando ti ritrovi all’interno di un gruppo di persone, ad un certo punto, dal nulla, sbuca il Demone Fankülizzatore, eterno vincitore, che istiga uno ad uno i componenti nel manifestare antipatia verso uno o più membri, fino a rendere l’aria pesante ed irrespirabile, spingendo il Fankülizzato (o i Fankülizzati) ad uscire dal gruppo (come Jack Frusciante), sempre che non venga cacciato prima. Poi il gioco riprende e ad ogni manche ci saranno delle esclusioni (come nei realities), finché rimane una sola persona a confronto con il Demone…e chi perde, secondo te? Ecco, ora hai capito come ci sono arrivata. Quel perdente ero io. Sono io.
Riguardo ai modi in cui ho tradito me stessa, beh, ho iniziato presto, direi. Da che ho memoria, per accontentare gli adulti ed essere meritevole del loro amore, ho sempre acconsentito ad accettare senza discussioni le loro scelte, anche quando non mi rappresentavano per niente, anzi, non le sopportavo proprio! Stesso discorso nelle amicizie: per sentirmi considerata dalle mie compagne di classe o di danza, mi rendo conto solo ora di essermi resa piccola, perfino invisibile, o comunque non brillante o espansiva come avrei potuto. Chi mi conosce oggi stenta a credere che fossi una bimba silenziosa e timida…non è che sia cambiata, semplicemente ora non mi nascondo più. Non mi vergogno più.
Ho tradito me stessa tutte le volte che, tra la mia serenità e quella altrui, ho scelto la seconda, perché credevo realmente che questo mi avrebbe garantito anche la prima. Ho voltato le spalle alla me più essenziale quando ho evitato consapevolmente di ascoltare quella parte più profonda che mi implorava di seguire ciò che gonfiava il mio cuore di gioia e trionfo, solo perché il dimostrare umiltà è ciò che viene richiesto ad una brava signorina o perché il celebrare i propri successi genera invidia e l’invidia guasta i rapporti. Come quando, reduce dal divorzio, stavo ritrovando residui di amor proprio e pulviscolo di autostima e ho ben pensato di cacciarli sotto a un tappeto per non infastidire colei che ritenevo una fidata amica, la stessa che, quando smettevo di annaspare ed alzavo la testa grazie a qualche espressione talentuosa, mi liquidava ben poco amorevolmente con un “fly down”.
(Ancora mi chiedo come possa la mia felicità generare infelicità in chi mi sta accanto e dice di volermi bene. Boh? Hai qualche idea? Sai anche dirmi perché ci sia più piacere nel condividere i momenti di dolore che quelli di gioia? Se ti viene in mente qualcosa, dimmelo, ti prego).
E poi penso a tutte le volte in cui non mi sono difesa, o meglio, in cui non ho preso le difese di quella mia bambina interiore che veniva costantemente ferita da critiche e commenti sarcastici da chi, invece, avrei voluto che mi sostenesse o, semplicemente, amasse, anziché tentare di sminuirmi e spegnere la mia luce. Elemosinavo amore anche quando facevo i lavori di casa controvoglia e senza chiedere una mano, pensando che se non mi veniva data spontaneamente era perché l’altro non poteva farlo, aveva cose ben più importanti che richiedevano la sua attenzione.
Potrei davvero continuare all’infinito, ma siccome non mi piace piangermi addosso e, di solito, con la giusta dose di indignazione riesco a scrollarmi di dosso il pessimismo e fastidio ritornando ad essere simpatica perfino a me stessa, ti confesso un’illuminazione sul tema, sempre che ciò non ti annoi. No? Posso continuare, allora…
Se c’è una cosa che in questo preciso istante mi sale ribollente in superficie (come il caffè nella moka), è la preposizione semplice “di”, con funzione di complemento di specificazione. Sono sempre stata “qualcosa di…”, e qui inizia un altro elenco interessante:
- amica di…;
- cugina di…;
- ragazza di…;
- collega di…;
- partner di…;
- moglie di…;
- figlia di… (evita qualsiasi battuta di dubbio gusto, per favore!)
Coltivo la speranza di combinare qualcosa di importante e di essere ricordata o citata semplicemente con il mio nome. Non voglio sembrare ingrata, ci mancherebbe. È che, una volta tanto, vorrei davvero potermi presentare con fare trionfante a quella bambina ferita e condividere con lei un successo, un risultato meritato, guadagnato, conquistato, con le mie sole forze. Sì, lo so, tutto ciò che siamo e facciamo lo dobbiamo a qualcun altro. Siamo costantemente interconnessi a tutto e a tutti, quindi è impossibile essere totalmente soli, nel bene e nel male. Eppure una piccola soddisfazione posso togliermela?
Non dici niente, quindi immagino tu sia d’accordo con me. Apprezzo la tua empatia, forse anche a te sarà capitato qualcosa di simile. Allora, condivido piacevolmente con te una scoperta. Ricercando l’etimologia della parola tradimento, ho trovato qualcosa di molto curioso: il termine deriva dal latino tradĕre, che significa consegnare, affidare, dare con fiducia. Il verbo è composto dalle particelle “tra-“, che significa oltre e “dăre”, che significa dare, per l’appunto. In origine, tradĕre indicava l’atto di consegnare qualcosa ad un’altra persona, ma il significato si è evoluto per includere il concetto di “tradire”, ovvero venire meno ad un impegno o a una fiducia. In particolare, il significato di “tradimento” si è sviluppato a partire dall’idea di consegnare qualcosa al nemico o di infedeltà ad un accordo. Questo significato è ancora presente nella lingua italiana, dove “tradimento” è utilizzato per indicare la rottura di una promessa, un dovere o una relazione di fiducia.
Capisci? Tu dai il tuo cuore a qualcuno e questo se lo dimentica in un taschino e nel frattempo se ne va in giro a dare il suo a qualcun altro. Per dire! Oppure ci sputa sopra, lo calpesta, lo maltratta, come se non avesse valore. In tutto ciò, quello che più mi tocca è il discorso sulla fiducia. Eh sì, perché non è tanto il tradimento di per sé, quanto il fatto che poni la tua fiducia su una persona e, se vieni tradito, la fiducia se ne va in un istante, si svaluta e, cosa perfino peggiore, poi non riesci a concederla se non con estrema difficoltà e diffidenza a qualcun altro, che magari se la merita pure.
Posso sprecare fiato citando quegli aforismi che dicono che quando tradisci qualcuno, in realtà, vieni meno ad un patto con te stesso e che, se lo fai una volta nulla ti vieta di rifarlo, perché ormai hai capito che puoi sopravvivere (visto che sei tuttora vivo): so di traditori che li sussurrano all’orecchio dell’amante di turno o li rinfacciano ai traditi prima di venire accusati con tanto di prove inconfutabili (che, puntualmente, vengono negate).
No, quella della ragione non è una strada percorribile. Le ho tentate tutte, sai? La verità è che ci ho messo un po’ per capire, per perdonare (anche me stessa) e lasciar andare, ricucendo brandelli di cuore e dignità e cercando di ricamare le ferite con qualche filo di fiducia. Una sorta di Kintsugi emozionale, quella tecnica giapponese che rimette insieme i cocci incollandoli con l’oro. Ad essere onesta, la medicina più potente (almeno per me) è stata la gratitudine, ma non quella così per dire, quella vera, percepita nel profondo e dal profondo emersa ed espressa verbalmente o con i gesti. Quella mi ha riparato, sia nel senso di riaggiustato che di difeso. E adesso che ci penso, sto già meglio. Vedi, funziona ancora! Mi sento già un po’ meno sconvolta e schizzata.
Sai che c’è? Facciamo che ringrazio anche te per avermi prestato ascolto con le tue orecchie pelose. Per avermi fatto le fusa mentre mi lasciavo andare a queste confidenze.
Hey, ma dove stai andando? Ti ho perfino portato una ciotolina di latte e qualche croccantino, gatto ingrato! Non voltarmi le spalle mentre ti parlo…Argh!
Francesca Tuzzi, insegnante ed operatrice olistica, esperta di sciamanesimo hawaiano, tolteco, reiki, shiatsu, kinesiologia emozionale ed altre discipline olistiche. Autrice di numerosi saggi, poesie (in rima baciata e incrociata) e racconti brevi, tiene corsi e conferenze ed organizza eventi (nazionali ed internazionali) sulla coscienza collettiva e sul benessere a 360°. Ballerina, sognatrice e visionaria. Adora parlare, viaggiare e mangiare e talvolta riesce a far collimare tutte e tre le cose.