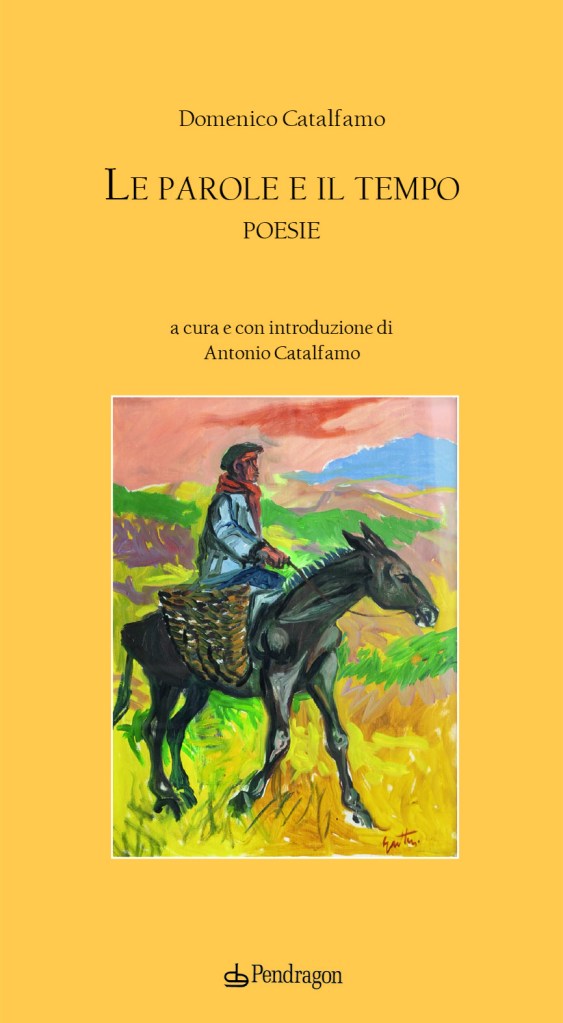
Domenico Catalfamo è nato a Bafìa di Castroreale (provincia di Messina) nel 1937. Si è laureato in Lettere moderne all’Università di Messina con una tesi in Storia sul pensiero economico dell’illuminista napoletano Giuseppe Palmieri. Ha insegnato per lunghi anni Italiano e Latino nei licei. Ha fatto parte, seppur con una posizione originale, del movimento letterario «Realismo lirico», raccolto intorno all’omonima rivista, pubblicata dalla prestigiosa casa editrice Ceschina di Firenze e al poeta e giornalista Aldo Capasso. Ha pubblicato poesie e articoli di critica sulla suddetta rivista, su «Artestampa», edita da Sabatelli Liguria, sotto gli auspici dello stesso Capasso, e su «Zootecnica e Vita», rivista accademica nata all’Università di Messina, per iniziativa di Nino Pino, scienziato e umanista, all’insegna del superamento della barriera preclusiva creata nella tradizione culturale italiana, d’impronta crociana, per separare artificialmente (e artificiosamente) sapere umanistico e sapere scientifico.
All’impegno culturale ha affiancato quello politico-amministrativo. Consigliere comunale a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) dal 1960 al 1962, a Castroreale dal 1962 al 1968. Assessore alla Cultura e vice-sindaco in quest’ultimo comune dal 1968 al 1987, anno in cui non ha ripresentato la sua candidatura, ritirandosi dalla politica attiva, ma rimanendo fedele alla sua ideologia, fortemente influenzata dal pensiero di Antonio Gramsci. Dirigente sindacale della C.G.I.L. e dell’Alleanza dei contadini. È stato, inoltre, Consigliere della Comunità montana, dando un valido contributo alla stesura dello Statuto costitutivo.
Vede ora la luce un volume antologico di poesie che risponde ad un progetto delineato dallo stesso autore, il quale ha raccolto in un quaderno scritto a mano una selezione delle poesie composte in vari periodi della sua vita, divise in tre sezioni, che corrispondono rispettivamente al periodo di ritorno della vena poetica nella fase del pensionamento (1998-1999), al periodo giovanile (1957-1960), e, infine, alla fase che comprende gli anni 2000-2001, nei quali il poeta ritiene di dover prendere commiato dalla poesia e dalle persone care, cessando di scrivere versi, probabilmente perché pensa di aver detto tutto quello che aveva da dire.
La raccolta, che reca il titolo di Le parole e il tempo, è pubblicata dalle Edizioni Pendragon di Bologna ed è preceduta da un ampio studio introduttivo del figlio Antonio, docente universitario.
Domenico Catalfamo appartiene a quella vasta schiera di intellettuali del Sud che, lungo la scia segnata da Gramsci, hanno coniugato, nel secondo dopoguerra, impegno civile ed impegno culturale, per trasformare la «questione meridionale» in «questione nazionale» e realizzare un mutamento radicale dell’intero Paese.
Come Rocco Scotellaro, «sindaco-poeta» di Tricarico, egli offre al lettore una visione realistica del mondo contadino, basata sul rapporto dialettico tra passato, presente e futuro, nella quale l’angoscia esistenziale convive con la fiducia nel cambiamento. È questa la «dialettica dei tre presenti» di cui parla Concetto Marchesi, al quale Domenico Catalfamo si ispira. Ed è questa la caratteristica fondamentale del neorealismo in Italia. Le macerie, materiali e morali, della guerra sono ancora agli angoli delle strade e nella coscienza collettiva, determinano sofferenza, ma, nello stesso tempo, la drammatica esperienza vissuta spinge alla lotta per una società di liberi ed eguali. È il «sogno in avanti» di Ernst Bloch.
Elemento essenziale di questo rapporto dialettico è il dolore, che, al pari del Leopardi, viene proposto come elemento conoscitivo che, determinando consapevolezza, spinge all’azione.
Domenico Catalfamo, come Lucrezio, poeta a cui si sente molto legato, tanto da dedicargli una tesi presentata ad un corso abilitante, è consapevole che in natura ogni distruzione è accompagnata da una costruzione o ricostruzione su basi nuove. La vita umana è una continua lotta tra bene e male: anche quando provvisoriamente prevale il primo, il secondo è sempre in agguato, pronto ad emergere con la sua forza distruttiva. Per questo le conquiste rivoluzionarie non sono acquisite una volta per tutte, ma debbono essere continuamente difese e potenziate con l’azione politica organizzata.
Le parole sono usurate dal tempo, come la moneta di Mallarmé, ma bisogna continuamente rinnovarle, attribuire ad esse nuovi significati, anche rivoluzionari, ma, nello stesso tempo, recuperare la loro genuinità primigenia, tradita dall’uso spesso strumentale, retorico, demagogico.
Domenico Catalfamo ricostruisce la storia di miseria del mondo contadino in cui è nato ed è vissuto, in una Sicilia ancora semifeudale, che si intreccia con quella della sua famiglia. Rievoca con grande forza espressiva l’immagine del nonno pastore, che di questo stato di miseria è la drammatica personificazione: «Ti ricordo, nonno, / reduce dai monti, / il viso scavato / ed i capelli grigi, / i panni male asciugati / al focolare. / Sulla porta di casa / mi porgesti / il bianco pane / che a te stesso forse / e alla nonna / togliesti di bocca. / Pane prezioso, / in quegli amari tempi, / che custodivi tra le carni / e la camicia lisa / di pastore. / Dare non mi potesti / il vino del tuo sangue, / fatto acqua / nel corpo piagato. / Ora sei in me, / nonno, / col tuo cuore disperato, / di cristo bestemmiatore / senza peccato». È il Cristo «bestemmiatore» dei poveri, che ricorda quello di Ernesto Balducci, che giustifica le bestemmie del fabbro presso il quale faceva il garzone da bambino, le quali assumono un sapore rivoluzionario come sublimazione della sofferenza e come scatto di orgoglio contro un mondo che sembra immobile nei secoli e che pure bisogna far procedere in avanti.
Il nonno muore, nell’immediato secondo dopoguerra, per lo scoppio di una bomba, residuato bellico rimasto nascosto lungo una trazzera di campagna, occultato dalla macchia. Anche un bambino, amico del poeta, fa la stessa fine mentre gioca con ordigni. Il conflitto continua a mietere vittime innocenti, che funestano le giornate, anche quelle che potrebbero essere serene, assorbite dai riti della religiosità popolare, come le novene natalizie, che dovrebbero attrarre la fantasia e la sfera emotiva dei più piccoli: «Si usciva, / nei mattini di dicembre, / nelle strade ancora buie, / col nero senza stelle / del cielo. / Fasci di cannucce accese / ci facevano luce. / Chi saliva e chi scendeva / lungo i sentieri di capre. / Ci accoglieva in chiesa / il viso sanguigno / di un re pastore, / omerico suonatore / di ciaramella. / Festoni vivi di arance / e lume incerto di candele / per il rito / pagano-cristiano / della nascita. / Lì fuori era morto, / tra i poveri giochi di guerra, / il mio amico Natale».
Il poeta non ha nostalgia per i rapporti di lavoro che caratterizzavano il mondo contadino siciliano, ma per la sua sostanza umana, basata sulla solidarietà tra i poveri, e per quell’ambiente geografico ancora incontaminato, che con la componente umana costituisce un tutt’uno inscindibile, superando la distinzione tra mondo degli uomini, mondo animale, mondo vegetale. È questa «indistinzione», secondo Carlo Levi, che rappresenta lo spartiacque tra l’universo contadino e quello industriale. L’impegno, lo studio, consentiranno di conservare questa sostanza e, nel contempo, di proiettarla in avanti, verso nuovi rapporti economico-sociali e politici: «Il lunedì partivo / col mio zaino di studente / e mi inseguiva sulla provinciale / l’ansioso richiamo di mia madre. / Presa una strada fuori mano, / avanzavo prudente, / fra case operose / incassate tra i monti. / Il vocale / melodioso del merlo / dominava la valle, / in un duetto / perfetto / con l’usignuolo. / Di volata mi ritrovavo / sul greto di sassi. / E il mugnaio, / davanti il mulino, / col suo volto luciferino / mi salutava. / Poi, non visto, / salivo / i gironi del colle, / per riemergere ansante / nella gloria del sole, / nei coltivi un sorriso di viole / e negli occhi il colore / dei ciclamini. / E laggiù, / come nate dal mare, / le isole favolose del dio, / appena disegnate / nel tenero azzurro del cielo, / e il mio umile entrare / nelle strade di ieri, / aspettando, palpitante, / il domani».
La mente del poeta va ai compagni di un tempo, che sono morti nel fuoco della lotta, ma che ora sono stati traditi dal trasformismo politico, dall’abbandono degli ideali, e persino dei simboli, del comunismo: «Cari compagni vi scrivo / a un indirizzo che non so. / Mi avete lasciato andandovene / in questa terra straniera, / in questa grigia sera / dove le luci si spengono / ad una ad una. / Quando vi trovo al cimitero / mi sembra ancora di partecipare / alle nostre riunioni, / quelle del partito vero, / nelle stanze anguste / delle borgate, / nei magazzini di campagna, / nelle legnaie di montagna, / a dire la propria / e ad aspettare la parola / che aprisse la porta / dell’avvenire, / seduti stretti sulla panca / dopo la giornata stanca / di lavoro. / Compagni è finita, / non verrà quella vita / che avete sognato. / Le serpi pasciute / nel povero seno / hanno imparato l’arte, / l’hanno messa da parte, / trovando rifugio / nella casa ospitale / del capitale, / esperti di banca, / di economia, / hanno trovato la via / che li porta lontano, / nel fango dorato / della vergogna, / sepolcri imbiancati, / coi vestiti firmati, / che si sono comprati / coi trenta denari / del tradimento. / Addio compagni morti, / forse un giorno risorti / per la speranza».
Ma questi compagni traditi risorgono, alimentano in chi è ancora vivo la speranza del cambiamento, che si nutre della loro memoria, del loro esempio e della loro lotta, che stimola a continuare lungo la stessa via.
Ai figli Domenico Catalfamo non lascia in eredità beni materiali, ma se stesso e i propri ideali, affinché continuino la sua azione e li trasmettano agli altri: «Non vi lascio, miei amati, / estesi giardini, / con viali d’ombra e di sole, / neppure un orto vi lascio, / con fichi / e limoni nani. / Non una magione / con ampi saloni / e verdi verande fiorite, / e neanche una casetta / alla svolta del vicolo. / Non vi lascio / un grande nome da spendere / come un conto illimitato. / Solo uno smilzo me stesso / vi lascio / che la vostra memoria forse / cancellerà. / Ben altro avrei voluto lasciarvi, / dopo avervi cresciuto col fiato, / qualcosa più grande / del cielo e del mare, / una verità, / un bene per voi / e per tutti. / Ma non è stato possibile. / Vi lascio / quello che tutti i poveri / lasciano, / vi lascio voi stessi / e spero che le vostre mani / possano spingere il mondo / dove le mie / non hanno potuto. / È poco, lo so. / Ma che la speranza / possa avere la forza / per camminare».
Il poeta attribuisce una grande funzione alle mani, all’azione rivoluzionaria. Quelle mani che, secondo Marx, hanno distinto, con la loro possibilità di articolazione, l’uomo dagli animali, costituendo, attraverso l’idoneità al lavoro, oltre che lo strumento per il suo sfruttamento, anche quello per il suo riscatto: «Mani pazienti e accorte / il bimbo appena nato / consegnano alla madre, / all’abbraccio dolce e dolente / della datrice di vita. / Mani di fata che spargono / nuvole e rose / sulla tela faticosa. / S’intrecciano le dita / di donna innamorata / a quelle del suo sposo. / Mani tremanti per le carezze / di un amore segreto. / Passano i sogni per le mani / di tutti gli esseri umani. // Mani che accendono / i fili della tortura, / mani di mostri che strozzano / il grido del giusto, / mani di assassini, / mani viola di morti, / mani mozzate / che non possono più sbagliare / né correggersi, / che non possono più operare / per il dolore e la gioia. // Mani operaie che tagliano / e annodano fili, / che spingono carriole, / che costruiscono muri e bastioni / per la civiltà e la barbarie, / per il bene e il male del mondo. / Mani che scarne si tendono / a ricevere infine la morte. // Mani della pace, / di tutti i fratelli / e le sorelle del mondo, / strette nel patto / della comune felicità, / fermate per un momento la morte, / accendete per tutti /il sole della speranza».
Alle mani associa la parola libera, anch’essa strumento rivoluzionario, che trova nella poesia la sua sublimazione: «Togliete al poeta / la sua libera voce, / resterà come l’albero / senza frutti né fronde, / sarà come automa / che si muove / o che sta / nel regno comune / della necessità. / Più non lascia aquiloni / librarsi nel cielo, / non escono suoni / dalla cetra in disuso. /Rimane una cosa / che non vive / e non posa, / ma inerte si chiude / nel grembo di morte».
Scopri di più da Liberi di scrivere
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.
Tag: Antonio Catalfamo, Domenico Catalfamo, Le parole e il tempo, Pendragon
Lascia un commento